Quando verso la metà del 1800 Johan Suter, pioniere svizzero prontamente ribattezzato John Sutter dagli anglofoni, trovò per caso un grosso filone aurifero nei pressi del fiume Sacramento, cercò ovviamente di non far trapelare la notizia, consapevole che l’oro fa sugli uomini l’effetto del miele sulle formiche; e tutto quel miele se lo sarebbe volentieri tenuto per sé. Ma il miele odora, e le formiche accorrono, che si voglia o no: in pochissimo tempo giunsero quindi all’estremo Ovest del continente un’infinità di avventurieri, che speravano di far fortuna trovando magari nuovi e abbondanti filoni. Speranza vana: si scoprì in fretta che il prezioso materiale non era poi così abbondante e pochi si arricchirono sul serio. La corsa all’oro si esaurì allora quasi più rapidamente dell’avventura tra i pro di Rafael Araujo; ciò nonostante, da questo periodo in poi la neonata California, istituita solo nel 1846, si vide elargita del titolo, mai più tolto, di The Golden State.


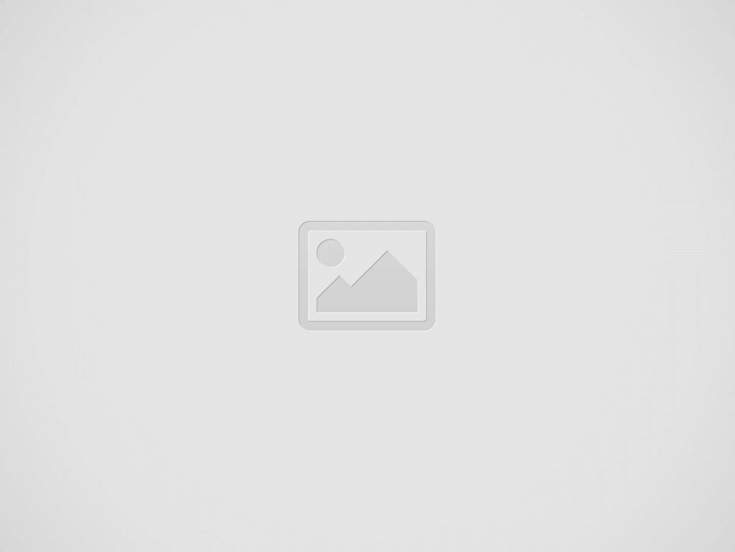

Quando nel 1962 il produttore Franklin Mieuli divenne azionista di maggioranza dei Philadelphia Warriors se ne infischiò altamente della storia che la franchigia aveva scritto: presenti dal giorno uno (unici con Knicks e Celtics), primi leggendari campioni BAA nel 1947 e di nuovo campioni, stavolta NBA, nel 1956. Voleva che la sua squadra avesse sede a San Francisco, e così prese baracca e burattini, soprattutto quello più grosso con la maglia numero 13 che pochi mesi prima ne aveva scritti 100, e li portò tutti nella Bay Area. Non contento, dieci anni dopo l’eccentrico magnate decise di spostare stabilmente la sede delle gare casalinghe, che divenne Oakland, e soprattutto di cambiare il nome, utilizzando quella denominazione che lo stato aveva acquisito più di un secolo prima: così i neonati Golden State Warriors divennero la prima e unica franchigia a non avere esplicite indicazioni geografiche nel nome societario.
Non lo poteva sapere, ma così facendo lo storico proprietario dei Warriors diede alla propria franchigia il nome perfetto per le caratteristiche peculiari che essa assunse nel corso degli anni: una squadra generalmente non particolarmente gloriosa, che molto spesso si trovava in vacanza già ad aprile ma che, come i cercatori che coniarono il soprannome statale, ogni tanto trovava un vero filone d’oro, una squadra entusiasmante che andava oltre ogni aspettativa, unendo peraltro risultati sorprendenti a un gioco quasi sempre spettacolare. E, proprio come un filone d’oro, ognuna di queste squadre finiva puntualmente con l’esaurirsi troppo in fretta, quando tifosi e semplici appassionati avrebbero voluto godersi ancora lo spettacolo.


Il primo di questi giacimenti lo trovarono quasi subito, come se il cambio del nome avesse portato un improvviso incremento del fattore C: guidati dal mitico Rick Barry e dai suoi caratteristici quanto infallibili liberi dal basso, i Warriors già nel ’75 arrivarono a sorpresa fino in fondo, partendo non certo come favoriti ma finendo con l’umiliare i ben più quotati Bullets in Finale, che non riuscirono a portare a casa nemmeno una misera doppia vu.
Dopo questo primo filone, inaspettato e abbondante come lo fu quello scoperto da Sutter più di un secolo prima, i successivi non si rivelarono altrettanto redditizi. Titoli non se ne videro più sotto il Golden Gate, ma non per questo mancarono versioni dei Warriors altrettanto importanti, e forse più caratteristiche ed entusiasmanti anche dell’antenata iridata. Denominatore comune di queste squadre era l’orientamento spiccatamente offensivo, con un gioco veloce e spettacolare che difficilmente non divertiva anche il più acerrimo dei detrattori; questa caratteristica ricorrente, manco a dirlo, si deve a un autentico pioniere di questo tipo di gioco, quel Don Nelson che in un modo o nell’altro ci mise sempre lo zampino. A cominciare dalla rivoluzione copernicana dell’esperimento dei Run TMC di fine anni ‘80, con i quali fissò i termini dell’embrionale concetto di Run & Gun, corri e spara, fino al clamoroso upset dei playoff 2007, quando al suo ritorno a Oakland si prese la propria personale rivincita eliminando i Mavericks da 67 vittorie stagionali (avete letto bene, 67, a sole 5 dal record dei Bulls di Jordan), con la solita squadra tutta corsa e tiro pesante, guidata da un Barone a tratti commovente.


L’allenatore ex Dallas non riuscì a ripetere quell’impresa (uscirono al secondo turno per poi mancare sempre i playoff) e i Warriors ricaddero nella mediocrità, perdendo progressivamente gli eroi del 2007 fino alla dipartita dello stesso coach Nelson, il quale, dopo aver superato Lenny Wilkens per maggior numero di vittorie in carriera nella storia (peraltro senza mai vincere un titolo da allenatore), lasciò definitivamente la franchigia nel 2010. Il suo insegnamento non finì però con lui: dopo la parentesi di Keith Smart, nel 2011 divenne capo allenatore Mark Jackson, ex disciplinato playmaker, profondo conoscitore del gioco, nonché assistente di Nelson proprio ai Warriors, da cui trasse l’ispirazione offensiva e il gioco veloce, aggiustando però anche la fase difensiva e non rinunciando a un lungo di ruolo. Il resto, come si suol dire, è storia: la scelta di Klay Thompson e la conseguente rinuncia a Monta Ellis, le firma di un’ala con punti nelle mani come David Lee, e soprattutto la definitiva consacrazione di Stephen Curry, scelto nel 2009 e troppo spesso limitato da problemi alle caviglie. Una prima stagione di aggiustamento, poi l’esplosione di due anni fa (2013), culminata col ritorno ai playoff, la spettacolare serie vinta contro i Nuggets e la battaglia con gli Spurs, che sudano molto di più per domare il figlio di Del e compagni rispetto alla successiva finale di conference coi Grizzlies. Insomma, sembra proprio che un nuovo filone d’oro sia stato scoperto, e che la polvere della lottery sia solo un lontano ricordo.
Tutto molto bello, ma adesso? Già, perché la squadra è buona, ma troppo spesso nella storia dei Warriors squadre apparentemente destinate ad essere protagoniste per anni sono naufragate tra infortuni e scelte rivedibili. Se Howard avesse deciso di cambiare maglia ma non Stato ora potremmo dire con sicurezza di avere una contender in più; così non è successo, e l’agghiacciante Dwightmare si è concluso con un nulla di fatto per i nostri. Alcuni sono partiti (Landry, Jack), altri sono arrivati a rimpiazzarli (Speights, Douglas, O’Neal); ma soprattutto si è unito al progetto un All Star come Andre Iguodala, dici niente. Già, Iggy: arriva in una squadra sostanzialmente già coperta nel suo ruolo (3 o 4 tattico), porta tanta solidità difensiva ma forse meno potenziale offensivo di altri esterni, soprattutto per quanto riguarda il fondamentale tiro da fuori. Il problema, se di problema si può parlare, potrebbe essere allora proprio l’inserimento di un giocatore del suo calibro in un aggeggio che funziona. Il perno, ovviamente, sarà ancora l’ultimo esponente della grande tradizione di guardie realizzatrici che hanno vestito questa maglia, quel Steph Curry degnissimo erede dei vari Richmond, Hardaway, Davis, Ellis, forse addirittura di Rick Barry se le malandate caviglie dovessero tenere.
EDIT: le caviglie han tenuto, decisamente, tanto da sollevare il peso non indifferente di un Larry O’Brien Trophy. Merito delle articolazioni finalmente stabili di Steph, del “fratello” Klay, di tutto il collettivo; ma merito anche del nuovo capo cercator… allenatore, che viene da lontano e risponde al nome di Steve Kerr. Colui che in quanto a ritrovamenti auriferi aveva imparato moltissimo in gioventù, in quella costa Est al tempo cuore pulsante dell’America cestistica, grazie agli insegnamenti di un paio di Re Mida d’eccezione come Michael Jordan e Phil Jackson. E che, come gli avventurieri di un secolo e mezzo fa, alla fine ha fatto fortuna a Ovest, nello Stato dell’Oro per eccellenza. Scoprendo e valorizzando un filone più ricco persino di quello del buon John Sutter. Il quale peraltro pare ancora lungi dall’essere prosciugato…

