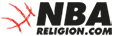Federico Buffa è considerato il maggior esperto di basket a stelle e strisce e forse il miglior narratore sportivo in circolazione. Fantastiche sono le sue storie targate tutte “Federico Buffa racconta…”, eppure c’è una storia che ancora manca e che il tifoso NBA italiano vuole conoscere: la sua. Grazie alla magnifica intervista riportata dal sole 24 ore andremo proprio a scoprire le avventure giovanili del nostro-vostro idolo.
Come cominciano i tuoi rapporti con l’America?
C’è mio padre che vorrebbe farmi fare al liceo un anno negli Stati Uniti – che all’epoca era una cosa abbastanza traumatica – perché conosce una persona il cui figlio lo fa. Io vado in una sorta di ritiro preliminare sul lago di Como di sabato mattina e vengo tagliato al primo turno: «Inadatto al mondo americano», al che mi sono abbastanza rassegnato. Mi immaginavo giocatore di calcio della squadra e immaginavo che sarei stato piuttosto forte rispetto ai miei coetanei degli anni Settanta americani. Mi avranno ritenuto chiuso e ombroso e quindi inadatto ad andare negli Stati Uniti per un anno. Non mi sono mai perdonato di non esserci andato.
Giocavo a pallone e mi proiettavo nell’idea di «Cazzo, vado là e faccio la star!». Stava per andarci Chinaglia e credo ci fosse già andato Pelé o Bobby Moore. Io ero quello che oggi sarebbe un trequartista, mi piaceva tanto, ero sicuro che da grande avrei fatto quello lì. È la prima volta che lo racconto. A questo punto mio padre mi imputò: «Ecco, hai visto? Sei il solito, guarda come ti sei comportato!». Ho detto «Vabbè, sono un quindicenne, papà, son problemi dei quindicenni», e lui mi disse «Non mi arrendo», e per la maturità mi regalò una summer session a Ucla (1). Sociologia.
La Summer School durava quarantacinque giorni… Ma io sono andato da un professore e gli ho detto: «Prof, non mi faccia neanche fare l’esame perché sono stato picchiato dal mio compagno di stanza taiwanese perché avevamo degli orari diversi e lui si incazzava». Era uno psicopatico. Dopo il viaggio ho capito che quel posto lì sarebbe stato la mia destinazione perenne. Ultimamente mi sono messo a contare e ho superato i cento visti.
Lì a Ucla la prima volta ho visto giocare Chamberlain (2): il mio imprinting è Chamberlain… Aveva 45 anni ed era retired, ma d’estate vivendo a Bel Air veniva a giocare le partite con gli ex Ucla e quelli che risiedevano in zona, in campi coperti, 5 contro 5… Gli anni dopo sono sempre tornato a Ucla a vedere le partite. Andavo tutti i pomeriggi e il secondo anno c’era Magic Johnson, che era già il padrone… Come farà col Dream Team (3), fischia lui, ci dà i falli… E ha fischiato: ha deciso che Chamberlain aveva fatto passi… Chamberlain allora disse «No more layups in this gym!» [più o meno, «Non ti faccio più avvicinare al canestro», ndr]. Gli ha stoppato ogni tiro da lì in poi. Ma mandandogli la palla a San Diego eh… Aveva 45 anni…
E be’, tornato a Milano mi presento da Aldo Giordani a Superbasket. Il suo ufficio era una roba, c’era di tutto e mi domandavo lui come potesse trovare le cose. Consegno il mio pezzo sull’America. Lui: «Mah, do un’occhiata…». Una settimana dopo l’ha pubblicato. Poi da lì in poi lui mi ha detto: «Vabbè, ma se tu vai così spesso in America scrivi qualcosa perché mi diverte», e da lì ho iniziato a collaborare. E diciamo la mia carriera nasce così. Un giorno porto Flavio Tranquillo a conoscerlo…
Flavio l’avevo conosciuto così: mi avvicina a un campetto perché mi aveva sentito alla radio che commentavo l’Olimpia e lui con la tessera d’arbitro poteva venire di fianco a me in tribuna stampa, a tenere i punti… Io dico: «Ma questo è un fenomeno», lo porto da Giordani (4) e insieme la domenica noi stiamo con lui, perché il Superbasket per noi era praticamente la Stoà, cioè lui arrivava e questo Aristotele di pensieri ci parlava, ci raccontava questi aneddoti che poi tendeva a raccontare continuamente, e noi li sapevamo tutti, ma non importa… A parte il fatto che noi mangiavamo gratis in questo ristorante vicino alla Stazione Centrale, dopo che avevamo chiuso i pezzi, quindi alle 22.30-23, lui prendeva sempre una bottiglia di rosé, un vino che si chiamava Rivera, mangiava sempre i tortellini in brodo e poi… Era Aristotele e la Stoà, soltanto che anziché camminare, ché non era peripatetico, era stanziale, sedeva, ma non ci guardava in faccia: lui parlava e noi dovevamo, come con un maestro giapponese, rubare senza che lui potesse ripetere o insegnare, noi rubavamo la parola e la gestualità… Naturalmente, noi sentivamo tutte le sue telecronache, io e Flavio le avremmo potute recitare a memoria…
Come noi le vostre.
Esatto, soltanto che prima di lui non c’era mai stato nessuno, quindi lui è il logos del gioco, nel vero senso della parola. Ancora adesso Flavio usa delle espressioni di Giordani di allora: «Non si può esimere», «stare in linea di galleggiamento». «Non può esimersi» arrivò da una partita di Varese contro Cantù, con Rusconi (5) allora playmaker di Varese… Cantù gli diede spazio per tirare raddoppiando continuamente Bob Morse, e su tutti gli scarichi, Rusconi che non tirava quasi mai aveva 3-4 metri di spazio… «Non può esimersi!» (dal tirare), e quella cosa è talmente restata che ancora adesso «Non può esimersi» è Rusconi a Cantù detto da Giordani…
Tutte le espressioni di Giordani, le americanizzazioni di Giordani: «Ventello», «Trentello», «Gara Uno», fu il primo che tradusse Game One con «Gara Uno» e lui italianizzava le parole americane…
«Alla giugulare» però è vostro?
Sì, può darsi… No, ma comunque lui non aveva mai forme cruente: lui veniva da un giornalismo degli anni Quaranta-Cinquanta che era più ridondante e mai cruento, mentre noi oggi possiamo parlare una lingua che è più vicina al linguaggio con cui si comunica normalmente, lui non avrebbe mai fatto così… Giordani sapeva la Divina Commedia meglio di Natalino Sapegno, aveva una cultura classica pazzesca, oggi non ci sono più giornalisti così, questa gente degli anni Cinquanta-Sessanta scriveva un italiano che oggi non si legge più e fa solo bene andarli a rileggere: il numero di vocaboli, come sono costruite le frasi, quella è letteratura italiana e lui era un eccellente giornalista che però aveva una modernità spaventosa e continuava a influenzare la sua lingua con la terminologia americana…
Lui traduceva dall’inglese frasi che in italiano non si utilizzano, per esempio «To make waves», «fare onde» [far casino, ndr], e noi leggevamo una frase che in italiano non aveva senso, che ne so, per esempio «Bruce Flowers fa onde a Notre Dame» e dicevamo «Ma che cazzo è “fare onde?”». Soltanto poi, apprendendo che in inglese si diceva «To make waves» dicevamo «Ah, ecco!». Quindi quella frase che in italiano non aveva senso, lui la introduceva, creando uno slang. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Non si può spiegare l’influenza di quell’uomo, è enorme.
Quali insegnamenti fondamentali vi dava?
Lui diceva: «Lo sport è attualità. Se noi usciamo il martedì non parlate della partita: dovete già pensare a quella successiva», cosa che non riusciva veramente a spiegare ai suoi corrispondenti, ma diceva a noi sul posto: «Non scrivete un pezzo sulla partita, perché lo leggeranno martedì o mercoledì, è passato».
Ritorniamo agli anni Settanta: è vero che tu giocavi nella squadra allenata da Tranquillo o è una leggenda?
Sì, ma dopo, sì… Flavio originariamente è il mio cambio, il playmaker in quella stessa squadra, ma – come, immagino, un Van Gundy della situazione – capisce che è meglio fare l’allenatore. E diventa il nostro allenatore.
Poi va pure a fare l’arbitro…
Anche io ho fatto l’arbitro: era obbligatorio all’epoca… Cioè, se tu ti volevi formare nel gioco secondo noi era fondamentale, a parte che si guadagnavano qualche centinaia di migliaia di lire, che potevano sempre far comodo: io mi ricordo tantissime domeniche mattina ad andare ad arbitrare le donne a Vanzago, a Parabiago, alle dieci la partita femminile dove facevano delle robe tragiche, mi presentavo con il mio vestito da arbitro del Csi con le righe verticali arancioni e blu. L’idea era questa: dovevi formarti e formarsi voleva dire arbitrare… Flavio ha questa cultura di gioco spaventosa, l’attenzione e la cultura della regola [imita la voce di Tranquillo, ndr], perché Flavio commenta la partita col regolamento lì…
Adesso con l’iPad non ha più bisogno di averlo perché ci va direttamente, ma fino a qualche anno fa metteva giù una serie di libri, che io chiamavo «Le tavole della legge», e sempre il regolamento, perché lui non può accettare l’idea, perché può succedere, perché il regolamento Nba è veramente complesso: che ci sia una situazione controversa, in varie occasioni è capitato, e allora lui prendeva un ideale timeout e diceva «Questa qui la riprendo dopo», mi faceva capire, e nella prima pausa andava a vedere. Flavio è capace di parlare e sfogliare senza cambiare il tono della voce, che è una cosa insensata…
Come eravate a 20 anni? Eravate due freak anche a 20 anni?
Be’, c’è una foto su internet… È una foto di noi due che stiamo andando a Grenoble a commentare la finale della Coppa dei Campioni 82 tra Milano e Cantù per Radio Press Panda. Guarda che randa che eravamo, specialmente il sottoscritto: però in quel momento capisci chi sei, più o meno, e per me era facile perché con lui io potevo parlare, noi abbiamo sempre parlato, come parliamo in telecronaca, non c’era in mente una soluzione di qualità, c’è solamente un tono più sussiegoso che in privato, ma originariamente abbiamo sempre parlato come eravamo dentro… Abbiamo usato la terminologia che usava Giordani con noi. Giordani aveva una radio che era fatta come una lattina di Coca-Cola, perché all’epoca era iniziato Tutto il basket minuto per minuto…
Sì, Giordani chiamava Flavio Tranquillo e me «I due fessacchiotti», anzi neanche «I due»: solo «Due fessacchiotti». Voleva dirci che ci aveva sentito commentare per la prima volta la partita alla radio, ma non ci avrebbe mai detto «Vi ho sentito alla radio» e quindi partiva così, al ristorante: noi siamo seduti lì e lui con i tortellini: «Oggi sentivo alla radio commentare la partita di Milano» (e ovviamente eravamo noi due, no?) «… Ma due fessacchiotti… Neanche male, eh… Secondo me…» («Dicci cosa vuol dire ‘sto “Secondo me”, dai!»). Cioè chiaramente ci voleva dire una roba, ma era così, sentivi il rumore del cucchiaio, la slurpata, «Due fessacchiotti, ma non male eh? Hanno ritmo, hanno ritmo» («Ma li conoscevi?», «Nooo, mai visti, mai sentiti»). Lui per la prima volta ci dava atto che stavamo facendo qualcosa, quindi per noi tutto nasce da «Quei due fessacchiotti».
Noi crediamo che quel giorno lui ci abbia praticamente autorizzato a cercare di trafugare la lingua che lui parlava, era una lingua che fondeva la pallacanestro americana parlata con la nostra, e lui praticamente disse, o noi pensammo che ci disse: «Dài, forza, vi autorizzo a completare la fusion». Ovviamente poi si aggiornò, perché lui non ebbe mai il privilegio di poter commentare il basket americano, lì sì che sarebbe stato divertente, Giordani con la sua lingua, col vernacolo di Giordani, parlando d’America…
E infatti Giordani soffrì sempre Dan Peterson da questo punto di vista, perché avrebbe sognato lui di commentare la pallacanestro americana e avrebbe fuso la sua lingua, che aveva creato per il basket, col basket americano…
Allora, qual è la storia delle trasmissioni dell’Nba (6) in Italia? Per collocare te e Flavio Tranquillo. Quando arriva l’Nba in Italia?
Arriva con la prima rete indipendente alla fine degli anni Settanta, io mi ricordo che vidi partite dell’Nba prima che arrivasse l’Nba in Italia e quindi io mi permisi di raccontare ai miei compagni di squadra cos’era l’Nba…
L’Nba si leggeva su Giganti del Basket, quindi quando nel mio primo viaggio in America vedo i giocatori a centrocampo, Chamberlain non posso non riconoscerlo, Greenwood e Magic Johnson pure… Ma, per esempio, Freeman Williams (7) chi cazzo è? Non l’ho mai visto in fotografia, me lo faccio spiegare da uno… Fino a Chamberlain i Giganti ci arrivano, dal quarto giocatore in giù no: cioè io tutti i giorni andavo ad aggiornarmi se per caso c’era uno che non c’era il giorno prima…
Allora, quindi l’Nba arriva in Italia nel 1979, proprio dopo il tuo viaggio in cui casualmente vedi Wilt…
No, c’è almeno un altro anno, credo che sia il 1980 allora, perché io mi ricordo di aver fatto un autunno solo di Nba. Avevo base a Chicago, dove ero ospite del direttore del teatro d’opera. L’accordo con mio padre era questo: io torno, più o meno a Natale, da lì in poi faccio solo esami, se il mio rendimento al 30 di giugno è quello che abbiamo concordato, io riparto e ritorno a Natale dell’anno dopo. Partivo il primo luglio e tornavo praticamente a Natale. Col Greyhound andavo in giro per tutti gli Stati Uniti tornando la notte a Chicago… Quindi mi ricordo perfettamente Gervin a San Antonio all’HemisFair Arena contro Denver, avrà fatto cinquanta punti, non ha fatto due punti uguali… Io così… Quindi tornavo e raccontavo ai miei compagni di squadra cos’erano veramente questi qua…
E com’era girare in Greyhound l’America? (Ma tuo padre che lavoro faceva?)
Sul Greyhound (8) c’era sempre un Silent Bob… (9) (Mio padre faceva lo psicoterapeuta…). Io però poi dovevo performare a scuola, eh, all’università… C’erano i militari, c’era questo mondo da Greyhound, la cosa che mi colpiva era vedere luoghi che nella mia memoria… Per esempio, Las Cruses, New Mexico. Perché mi colpiva tanto Las Cruses? Perché avevo visto che D’Antoni aveva perso la partita del torneo Ncaa (10) contro Southwestern Louisiana a Las Cruses, New Mexico, io sapevo tutte queste città e me le segnavo sull’atlante, poi volevo andare a vedere il luogo esattamente dov’era successo… L’autobus si ferma a Las Cruses alle quattro del mattino e a me sembra che siamo nel deserto, io non me la sento di scendere e sono andato alla fermata dopo, perché avevo paura fisicamente a scendere a Las Cruses alle quattro del mattino, ma io volevo andare a vedere dove si era giocata la partita…
L’Nba arriva, diciamo, nel 1980, l’era di Magic e Bird. Chi è il primo a commentare l’Nba? Dan Peterson?
Eh sì, e Peterson racconta delle storie incredibili… L’idea di inserire un concetto sociologico, politico, in una storia di sport, prendendo storie d’America, è Peterson. Peterson racconta delle storie d’America e le mette all’interno delle partite, è la seconda nostra grande iniziazione…
Le storie tu le raccoglievi nei tuoi viaggi.
Tu tieni presente che ci sono stati anni in cui, su quaranta giorni, avrò dormito trenta in Greyhound e mi cambiavo con un sistema raffinatissimo, avevo due paia di jeans, uno ogni tanto lo lavavo, e poi magliette… Una figata, col sistema che si viaggiava di notte io ogni giorno riuscivo ad andare in un’altra destinazione Nba… Le facevi tutte… San Antonio oggi? Tranquillo, io domani la partita a Denver la vedo, che problema c’è, viaggio di notte, arrivo magari due ore prima della partita… Il problema era tornare al Greyhound, quasi sempre cercavo di corrompere il mio vicino di posto…
Io ho fatto in tempo a vedere le due annate di Chicago che portano a Jordan (11). Cinquemila spettatori al Chicago Stadium, io praticamente andavo tutte le sere ed ero insieme al papà di uno di quelli che lavorava ai Bulls, che ormai non chiedevo neanche l’accredito, era una cosa tra amici, c’era Quentin Dailey che faceva casino… Perdendo sempre, poi è arrivato Jordan… E lì l’accredito era un po’ più complesso… Però una volta Virginio Bernardi, che adesso è procuratore degli allenatori italiani, all’epoca allenatore… Nel 1988 andiamo a Chicago perché il suo ex giocatore Mike Brown è un compagno di Jordan, quindi, anziché avere il solito posto scomodo, con Brown ce l’abbiamo a bordo campo… Io vedo il mio primo courtside game nell’Nba con Jordan in campo.
A un certo punto dico a Virginio: «Adesso scriviamo: contiamo il numero di volte in cui questo qua gioca sopra il ferro» e alla fine arriviamo tipo a quaranta giocate sopra il ferro consecutive, tu dal campo vedevi che lui giocava sempre sopra il ferro, cioè fa cinquanta salti e ogni azione è sopra il ferro… Vedere il basket Nba a bordo campo per noi era una roba… Ancora adesso io sono abbacinato, pensa allora, cioè tu vedevi sto qua che giocava sopra il ferro, anche quando non c’era bisogno giocava sopra…
Quando hai iniziato a fare le telecronache?
La prima telecronaca di Nba? Nel 1997, Lakers-Phoenix, la sera prima concerto di Gloria Estefan (12) con Flavio… Io ho fatto il college basket dal 1994 al 1997, con Claudio Arrigoni. Flavio dice tante cose in una telecronaca, cioè, si mescola, lui praticamente ti dice «Facciamo della fusion, non farlo come lo fai di là», cioè coi ruoli divisi.
Quello è il primo anno in cui intuisco che la mia vita è completamente cambiata, perché mi chiama il produttore di Tele+ (13) Michele Boccacci, che fa: «Si va all’All Star Game a Cleveland». «Scusa?!». «E si viaggia in business». «Cioè?!»: quindi per la prima volta negli Stati Uniti per commentare e la partita sarà quella dei 50 più grandi di tutti i tempi, con Karl Malone che chiede a Chamberlain l’autografo…
Peraltro, parlando di Malone, io sono quello che lo segue quando lui viene qua, dopo il primo anno a Utah, contratto di un anno perché non si fidavano di lui, viene qua a giocare per la Desio di Virginio Bernardi e firma un contratto, fatto firmare da me, di tre anni a 350mila dollari all’anno… Perché io lavoravo come avvocato per Warren LeGarie, che ci crea questo contatto, viene in Italia Karl Malone, chiaramente vuole combinare la cosetta con gli Utah Jazz e io…
Cioè ti sei preso una percentuale dei soldi di Karl Malone?
No, perché alla fine ha firmato con Utah, ma aveva la clausola d’uscita, poi a quel punto con Utah aveva 7 anni di contratto a una cifra leggermente superiore…
Com’è il tuo rapporto con l’Nba? Conosci molta gente nell’ambiente?
Devi pensare che è stato molto utile il rapporto per tanti anni con LeGarie: magari t’avevano già visto, la diffidenza iniziale era vinta… Un episodio: io cerco di convincere i Clippers a prendere Pippen al Portsmouth Invitational… Dico ad Andy Rosen, che Warren conosce, «Prendete Pippen, secondo me è fortissimo» e questo mi dice: «Ma neanche lo abbiamo mai visto», io lo avevo visto per una coincidenza… Warren mi presenta a Rosen, perché parlano di clienti che poi Warren ha nell’Nba… «Chi è lui?». «Uno dei miei uomini che lavorano in Italia…». «Ma come mai sei qua?». «Eh mi piace vedere i giocatori e poi quelli che qua andranno discretamente per noi potrebbero essere interessanti». Ma io sono appassionatissimo di lì e gli dico: «Ho visto per coincidenza una cassetta di Pippen semi-pirata» e dico ai Clippers «Guardate questo Pippen secondo me è fortissimo». Pippen fa un discreto primo giorno al Pit (14). Poi viene fuori che farà la scelta di andare con i Bulls…
Ora quando vai lì chi conosci?
Ci sono le persone fondamentali nella mia vita Nba che sono: il primo, Scotty Stirling, che all’epoca era l’ex scout dei Sacramento Kings… E i miei secondi genitori americani sono a Berkeley, dall’altra parte della baia di San Francisco, e io passo tanto tempo lì durante gli inverni e mi hanno presentato questo Stirling. Diventiamo amici, tutti e due viviamo in quella zona lì e dobbiamo andare alla partita e lui mi dice «Be’, ma andiamo assieme», e quindi io vado a Sacramento… Faccio avanti e indietro Berkeley-Sacramento con lui almeno venti volte… Guida lui… Due ore ad andare, due ore a tornare… Fai conto che nelle mie telecronache di cose che lui mi ha detto in quelle due ore ce ne saranno cinquecento… L’altro è R.C. Buford. Me lo presenta il compianto ex general manager di Torino e Reggio Calabria, Piero Costa, che è diventato agente, per qualche motivo lo conosce e me lo presenta… È un timido ragazzone del Kansas che poi diventerà il più bravo general manager dell’Nba…
Cioè, il general manager di San Antonio è un tuo mentore?
Sì, lui è l’altro che in questi anni mi ha raccontato più cose… Adesso vado a trovarlo.
E ci hai parlato di Belinelli (15) con lui?
Be’ certo… Mi ha telefonato esattamente il giorno dopo che io ho fatto l’intervista a Belinelli trasmessa su Sky… L’avrà vista, qualcuno gliel’avrà tradotta, e lui mi ha detto: «Parliamone un po’», e vado a trovarlo e faremo la classica giornata dove lui mi racconta della roba incredibile… E poi mi ha fatto vedere l’Nba dall’interno, lui ti mette nel suo ufficio, ti fa vedere le sue cose, l’allenamento…
Quindi tu hai visto nascere da dentro gli Spurs di Duncan e Popovich?
Infatti, al ristorante Mi Tierra, in occasione delle finali del 1999, Flavio e io convinciamo Buford a prendere Ginobili. Tieni presente che Buford poi era un uomo molto intelligente, molto raffinato… Allora mi ricordo una volta che mi disse: «Dai, trovami una bella bottiglia che devo guadagnare punti col mio allenatore».
Noi abbiamo dei privilegi che non si possono immaginare… Dovevi pensare che Gara 5, forse la più bella partita di finale che abbia mai visto, Detroit-San Antonio, vinta da San Antonio con il famoso tiro da tre di Horry… Buford viene da noi in albergo e noi andiamo a colazione insieme il giorno della partita e parliamo della partita con lui… Poi dici, nella telecronaca Flavio sembra che conosce le cose… Ma grazie, le sa! Flavio ha la possibilità di parlare, perché conosce perfettamente D’Antoni e tanta altra gente… Flavio si può permettere di chiamare al telefono un allenatore, un general manager dell’Nba e parlare della partita che sta per commentare…
Parliamo di calcio. A Milan Channel cominci facendo questa cosa che nessuno fa, la «partita tattica» e lì io finalmente vedo i movimenti del Milan spiegati.
Io cerco di fare questa cosa perché mi piace, venendo dal basket, essendo quindi obbligatoriamente analitico, non sopporto l’idea che nel calcio questa parte sia completamente lasciata per conto suo e quindi provo a fare una cosa rivoluzionaria. A questo punto Bonan di Sky (16) dice: «Facciamo una cosa, io ho questa trasmissione di calcio mercato, vorresti qualche volta fare l’ospite?». Io dico: «Ma non so se sono all’altezza». Lui dice: «Tu vieni poi ti facciamo prevalentemente domande sul Milan». Quello che succede è che però dopo quella parte lì lui mi propone un programma la domenica, si chiama Sky in Campo, dove, per la prima volta, uno che non è un ex calciatore, ma un giornalista, viene messo di fianco ad altri giocatori…
Qual è l’esito di questa esperienza?
No, Sky in Campo fantastica, però bisogna dire che a Sky in Campo ci sono delle persone che io conosco, come Billy Costacurta, il problema qual è? Che quell’estate vengo preso da Federico Ferri, uomo molto in crescita in Sky, e mi mette a commentare stavolta la Coppa America, quindi alle due, tre del mattino e lì, purtroppo, questi qua mi propongono di andare al vertice di Sky cioè Sky Calcio Show, quindi io devo andare alla trasmissione di punta a parlare di calcio, ma non è più il mio calcio, perché non è né il Sud America, né il Milan… Io registro una puntata…
Quella trasmissione non è il mio genere e il contesto è molto poco adatto: io non amo il calcio per niente, il gioco lo amo da morire ma il modo in cui viene commentato in trasmissione a me non piace. Figurati, dopo che hai a che fare col mondo americano, dover arrivare in quel contesto è impraticabile. Io ho ricevuto una serie di telefonate di politica… Cioè c’è gente che mi ha telefonato dicendo: «Allora ora ti do la mappatura politica di Sky, questo è in quota questo…». Io l’ho interrotto e ho detto: «Io voglio parlare dei tiri di LeBron, lei di cos’è che mi vuole parlare esattamente?». E i giorni successivi addirittura un sms anonimo: «Calcio = voti, attento a quel che dici». Eeh?? No no, grazie… Io il martedì decido che per me è finita lì, il giovedì vado da Guadagnini, mio direttore dell’epoca, dicendogli: «Guarda, per me finisce qua».
Io non sopporto il buonismo del calcio, un sacco di cose non si dicono, non si possono dire e allora che cosa stai lì a fare… E se provi a fare qualcosa di diverso è un problema perché stai facendo qualcosa di diverso, quindi non è il mio posto, il mio posto, se c’è nel calcio, è provare a fare il narratore…
Cos’ha di speciale il calcio argentino per te?
Il calcio argentino secondo me è il calcio. Se vai là… Non lo so, i sudamericani guardano il calcio in un modo diverso dal resto del mondo, lo raccontano diverso, lo giocano diverso, lo vivono diverso e sono quelli che dicono: «Grazie, voi ce l’avete portato e adesso, a differenza degli altri, facciamo quello che vogliamo noi, il vostro calcio, bello, ma adesso lo giochiamo come lo vogliamo giocare noi, fermiamo il pallone e la tecnica individuale prevarrà sul vostro calcio».
Gli inglesi gli insegnano il calcio perché hanno degli interessi commerciali in quella zona del mondo e quindi i dopolavori delle aziende dove loro compravano la carne, diventano le scuole…
Come i club di tennis sul lago di Como dove andava Gianni Clerici… (17)
Esattamente così, tutte le squadre hanno un nome inglese che qualche volta spagnolizzano con Nacional, River Plate, Boca Juniors (18), Newell’s Old Boys, Racing… Però loro ti dicono: «Perfetto, ma noi lo facciamo diventare un’altra cosa», cioè questa idea della palla che deve andare sempre dritta per noi non esiste, noi la palla la fermiamo: e inventano un altro calcio basato sull’idea che il pallone si fermi e la tecnica individuale faccia la differenza… Quando l’Uruguay arriva alle Olimpiadi del 1924 in Europa, gli europei non hanno mai visto giocare a calcio così, questi qua scherzano… Hanno tutti nomi spagnoli o italiani e gli europei dicono: «Ma che cosa fanno questi? Non ti hanno fatto vedere la palla». Vincono le Olimpiadi del 1924, del 1928 e il Mondiale del 1930. Quindi loro riducono il campo in un altro modo rispetto agli inglesi e realmente il calcio sono loro, sono loro che creano il calcio come lo giochiamo oggi, tra il 1920 e il 1930, quando dominano completamente avendo ribaltato la linea inglese del gioco.
Che era a dieci uomini tutti buttati in avanti.
E la palla lunga: loro la fermano… È una metafora che i nuovi inglesi, gli americani, riprendono inventando uno sport, che in realtà è di origine inglese, basato sulla conquista del campo, che è il football americano… Football, rugby e calcio nascono assieme tutti e tre in Inghilterra. La metafora della conquista del territorio. Sport dove la palla va davanti. Ai sudamericani questo gioco non interessa, perché non c’è abbastanza cura.
ARTICOLO RIPRESO DA IL SOLE 24 ORE – CLICCA QUI PER L’ORIGINALE
Here we are con una nuova puntata di "Federico Buffa racconta...". Stavolta il migliore storyteller…
Il playmaker di New York è tornato ad allenarsi ma non ha ancora svelato la…
La compagina di Mitchell ha agguantato la 60esima vittoria stagionale
Un assistente promosso ad interim prenderà il posto dell’allenatore più vincente nella storia della squadra.
Incredibile epilogo tra Lakers e Chicago con la bomba da oltre metà campo di Giddey
NBA e FIBA hanno confermato lo sviluppo di una Lega europea in collaborazione
Il nativo di Akron ha trascinato i suoi alla vittoria con un tiro a fil…