Continua dalla parte 1.
Freedom and hoops. Ed effettivamente la sua vita era migliorata. Un posto da Burger King garantiva a lui e alla piccola Danisha un sostentamento. Caron tornò addirittura a scuola. “E quando calcai di nuovo il campo da basket, le paure della gente di trasformarono in applausi”. Con una frase molto larrybrowniana, si proclamava interessato solo a giocare nel modo giusto, agli ordini di Coach Ghuari. Nel suo anno da Junior a Park High, viaggiava a 24,3 punti 11,1 rimbalzi, 4,3 assist e 2,1 rubate, con tanto di premio di giocatore dell’anno della contea e inserimento nel quintetto All-Winsconsin.
Eppure, la vita decide che tocca a lui. Quando il peggior detective di Racine, Rick Geller, entrò in casa Butler con le mani in pasta trovò proprio Caron, che con la vendita di cocaina aveva smesso da un pezzo. Una volta entrato in un caso, Geller non mollava finché non aveva trovato ogni braccio del braccio del braccio del criminale in questione. Caron provò a difendersi con tutta la più buona volontà. Si vedeva già davanti ad un giudice, pronto per tornare dietro le sbarre. E invece Geller gli “fa cadere la mascella”, credendo ad un potenziale spacciatore. Una cosa che, gli racconterà poi, non aveva mai fatto in quasi tre decadi di servizio. Il detective, che nulla sapeva del talento di Caron, si vedrà poi omaggiare da una delle dediche più sentite:
“All’uomo che ha permesso tutto ciò, senza neanche sapere che giocavo a basket. Aveva solo visto che ero un ragazzo al posto sbagliato al momento sbagliato. Mise in gioco la carriera, ma fece la scelta giusta. Lo rispetterò sempre per questo”.


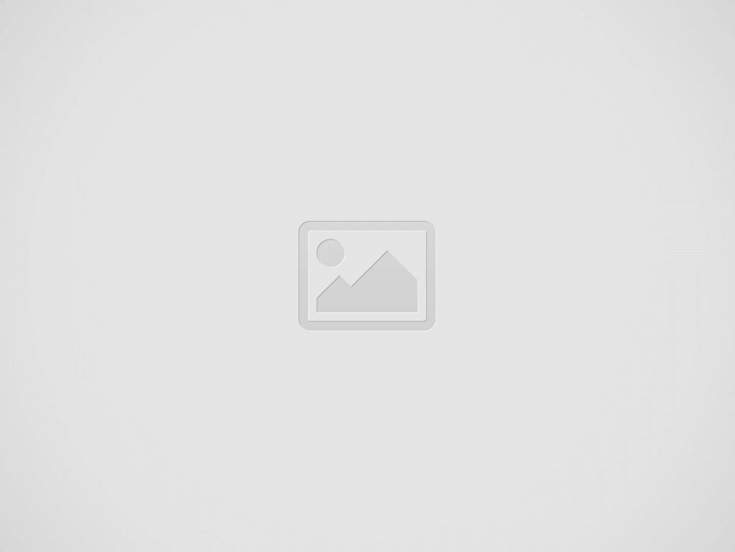

Mad Max. Caron era cresciuto così tanto da essere quasi 2 metri a fine liceo. Si fece un nome a Park High, tanto che Coach K e Coach Calhoun vennero a vederlo più volte. Ma non aveva voti abbastanza buoni per l’eleggibilità ad un major college: fu così che prese sul serio la chiamata di Max Good. Non che Maine Central Institute in quel di Pittsfield, Maine fosse il massimo, ma quantomeno il personaggio-allenatore era intrigante. Le prime parole che rivolge a Caron Butler (ossia un giocatore che non passa spessissimo da quelle parti) sono: “You motherfu*ker”. Dopo diversi prestiti di denaro (poi lautamente coperti), convintosi riguardo al Maine, riuscì a pagarsi i diciassettemila dollari d’iscrizione: andrà a giocare là. Il primo incontro tra il miglior giocatore della squadra e “Mad” Max fu bizzarro: dopo un lungo volo, l’allenatore fece accomodare la sua nuova stella sul sedile posteriore, per lasciare il posto al cane. Si fermarono al McDonald’s, ma il Big Mac fu dato al cane piuttosto che a Caron, alquanto affamato. Appena arrivati al centro di allenamento, Good indice una partitella: shirt vs skin alle due di notte. Viene dominata ovviamente da Butler, che schiaccia ogni volta che va dentro. Al quarto poster vincecarteriano, Mad Max ferma tutto e urla: “We don’t do that shit here”. Ma voleva solo accertarsi che il gioco valesse la candela, gli dirà in seguito. D’altronde, Good ha portato ben 10 giocatori in NBA, tra i quali Sam Cassell, Cuttino Mobley e Brad Miller. Non male per una piccola cittadina persa nel Maine. E finita l’avventura a MCI, nonostante Caron non avesse nessuno alla cerimonia del diploma, si ritrovò in cima alla recruiting list. Molto meglio che farsi altri dieci anni di gabbia.


Mad Max.
Marquette, Duke, Georgetown e St. John’s sono solo alcuni degli atenei che chiamarono. Ma la chiave fu una conversazione che Caron ebbe con Ray Allen, prodotto di UConn, scelto alla 5 nel ’96 dai Bucks. Jesus Shuttlesworth lo convinse ad andare nel Connecticut, mostrandogli quanto lui e Rip Hamilton siano divenuti forti sotto Coach Calhoun. Butler rimase impressionato: diventerà un membro degli Huskies. Una cosa l’ha apprezzata riguardo il reclutamento del Coach: non gli ha mai, per nessun motivo baciato il culo.
UConn. “Quando arrivai a UConn, la mia vita cambiò immediatamente. E non sto parlando di basket”. Noi sì però, dunque proverò a tagliare la parte, pur bellissima, di lui che fa figuracce per tutto il campus dell’università cercando di farsi notare da Andrea, tuttora amore della sua vita. Anche perché ormai siamo entrati in un’atmosfera cestistica. A UConn scopre un nuovo modo di giocare, un nuovo modo di vivere, di allenarsi, di vedere le relazioni. Immaginate un ragazzo di Racine, Winsconsin che dopo una serie di semafori rossi schivati si trova a giocare il Maui Invitational alle Hawaii. In una chiamata a casa, uno dei parenti (che da Racine, Winsconsin mai se ne era andato) chiese se si potesse guidare per raggiungere le Hawaii, in modo da vedere del vivo la prima partita universitaria di Caron. “Man, we are on a fucking island” – rispose lui.


Nella prima stagione di Butler a UConn la squadra nemmeno si qualificò per il torneo NCAA. E Coach Calhoun non si fece problemi a puntare il dito verso la stella (freshman) della squadra, parlando, davanti a tutti, di come le cose sarebbero andate diversamente se ci fosse stato Ray Allen. Deluso dai risultati di squadra, Caron decise di andarsene in NBA dopo un solo anno di college. Fu Calhoun a vietarglielo. Gli promise che sarebbe diventato un giocatore migliore nel suo anno da sophomore. E aveva ragione. Quell’estate giocò anche per Team USA con, tra gli altri, Carlos Boozer, Jason Kapono, Nick Collison e Jameer Nelson. Si convinse strada facendo che rimanere anche per il secondo anno gli avrebbe fatto bene. Anche perché, se Dio vuole, riesce a portare fuori a cena Andrea. Senza rancore Caron, ma potevi fare meglio di una Uno Pizzeria. Solo pochi mesi dopo, mentre nel cinema andava Danni Collaterali con Arnold Schwarzenegger, mise l’anello al dito di Andrea e le chiese di sposarla. Sorvoliamo nuovamente sulle circostanze, ma funzionò.
Sistemata la vita privata (Andrea aspettava un bimbo, tra l’altro), si torna al parquet. UConn vinse il titolo della Big East e Caron fu co-miglior giocatore della conference. E stavolta al torneo NCAA andarono eccome. Arrivarono alle East Regional Finals al Carrier Dome di Syracuse contro Maryland. Butler, ripensando a quella partita, la descrive come una sorta di finale anticipata: chi avrebbe vinto lì, avrebbe poi vinto the whole thing. Dopo un primo tempo passato per buona parte in panchina per problema di falli, fu lui ad alzare la voce nello spogliatoio all’intervallo. Gli venne un lebroniano: “Just follow my lead”. La rimonta era quasi completata, ma una bomba di Steve Blake a 25 secondi dalla fine chiuse i discorsi. E come predetto, Maryland batté Kansas e Indiana per vincere the whole thing.


Era il momento di salutare l’università, ringraziando di cuore. “I feel like I took a piece of UConn with me, and I left a piece of myself that will always be there.”
(Finally) NBA. Torniamo così al Draft di cui sopra. La prima offseason della sua carriera fu a dir poco traumatica: una disidratazione reiterata lo costrinse al ricovero in ospedale. “Rookie mistake n. 1”. La sua prima partita NBA, in casa contro Orlando, non la dimenticherà mai. Ripensando al primo canestro, invece, sorride: lo segnò da un tiro sbagliato di Malik Allen, che più tardi diventerà uno dei suoi assistenti allenatori ai Pistons. Fu una serata da 16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, in 34 minuti.
In una storia molto simile a quella di Rasheed Wallace a North Carolina, anche Caron fu introdotto alla vita notturna NBA dai veterani.
“Andai. Mi sbigottì come alcuni miei compagni lanciassero risme di banconote all’aria, divertendosi nel vedere la gente del pub che faceva a botte per raccoglierli. Era una cosa che semplicemente non potevo fare dopo tutto quello che avevo passato.”
Prima stagione voleva anche dire prime sere in back-to-back e magari in back-to-back-to-back. Ma quando dall’altra parte c’erano l’ultimo MJ, Kobe Bryant, Tracy McGrady e Vince Carter gli stimoli venivano da sé, nonostante la fatica. Imparò ben presto che i grandi nomi erano anche quelli che lavoravano di più lontano dalle telecamere. Uno degli aneddoti più interessanti lo fornisce riguardo Reggie Miller: nel pre-partita del pre-partita della trasferta ad Indianapolis, Reggie era già lì che tirava. O di quella volta che, celebrato il farewell party di Jordan a Miami, His Airness si fece avanti dicendogli di continuare a lavorare, perché aveva intravisto qualcosa. Chiuse l’anno da rookie a 15 e 5 di media, ma Miami ne vinse solo 25. Considerando che l’anno dopo al Draft sceglieranno Dwyane Wade…
Ma al primo giorno di training camp della stagione 2003-2004, Pat Riley (“a genius”) convocò la squadra. Con un discorso sul ritiro di Kareem Abdul-Jabbar, diede sostanzialmente le dimissioni da Coach. Al suo posto arriva Stan Van Gundy. Con l’aggiunta di Lamar Odom, la squadra era molto migliorata nonostante i diversi infortuni che penalizzarono Caron. Il record solo leggermente positivo (42-40) permise comunque un quarto posto ad Est. Il primo turno contro gli Hornets di Baron Davis fu vinto alla settima, mentre al secondo Indiana risultò troppo forte, trascinata da Jermaine O’Neal e Ron Artest. “Guardavo con serenità il mio futuro a Miami, avevo ottime sensazioni riguardo la squadra. Era chiaro, però, quanto dovessi imparare del mondo NBA”.


Odom, Wade, Butler: tris d’assi che, in realtà, nemmeno prese forma.
Di ritorno da un viaggio estivo con la moglie, infatti, appena sceso dall’aereo, un tifoso gli corse incontro congratulandosi per essere divenuto un Laker. Due giorni prima, Erik Spoelstra gli assicurò che non doveva temere: Shaquille O’Neal sarebbe sì arrivato in Florida, ma lui non sarebbe stato coinvolto. E invece… Fu una sensazione strana per lui lasciare Wade (“like a brother”) per andare con Kobe (“il vero coach di quella squadra”).
Un episodio sul bellissimo rapporto tra il Mamba e Caron. Nella trasferta dei gialloviola a Milwaukee fu Butler a fare da padrone di casa. Invitò la squadra a mangiare a casa sua, a Racine. Invitò tutti: da Lamar Odom (anche lui parte dell’affaire Shaq) a Sasha Vujacic. E quindi anche Kobe, che accettò senza pensarci. Uno dei tanti famigliari di Caron, visto Kobe Bryant seduto al proprio tavolo, chiese allo stesso Dio sceso in terra se anche lui mangiasse le costolette. E lui rispose: “Sì, e scoreggio pure!”.


La sua prima stagione (15,5 punti e 5,8 rimbalzi di media) nella città degli Angeli fu anche l’ultima. Venne di nuovo inserito in una trade a più giocatori che portò Kwame Brown a LA e lui nella direzione opposta: Washington. Se per Kwamone le cose non andarono benissimo nel parco-giochi di Bryant, andarono decisamente meglio per Caron: cinque anni nella capitale, chiusi a quasi 19 di media. Venne anche chiamato due volte per l’All-Star Game. L’allenatore di quella squadra, Eddie Jordan, fu “l’unico che divenne un amico personale anche al dì fuori dal campo”. Secondariamente, fu il primo ad affibbiargli il soprannome “Tuff Juice”. Il roster di quei Wizards prevedeva anche Gilbert Arenas, Antawn Jamison, Brendan Haywood e DeShawn Stephenson. “But looking back, we really fucked up a good thing”.
Ahhh, Gilbert. Tutte e tre le volte che andarono ai Playoffs, infatti, quei Wizards furono spazzati via dai Cavs di LeBron James. L’infortunio al ginocchio che impedì ad Arenas di giocare l’intera serie nel 2007 non aiutò, come del resto quello prima di Gara 5 l’anno successivo. Erano sotto 3-1 e il close game era in scena nella sala da ballo del Re. Prima di prendere l’aereo, però, la squadra venne informata che il presidente stava morendo per una rara forma di degenerazione cortico-basale. Fu lo stesso Abe Pollin a comunicarlo ai suoi giocatori, aggiungendo (pregando) i suoi di vincere quella partita per regalargli un’ultima grande gioia. Caron scrisse 32 con 9 rimbalzi e 5 assist, con tanto di tiro vincente in faccia al Re with 3,9 seconds remaining. Solo una volta tornati a Washington Butler ebbe la prima conversazione sulla pallacanestro con il proprio presidente: “He wanted to talk about real life”. Sfortunatamente, Gara 6 fu dominata da LeBron (27-13-13) e Abe Pollin morì senza mai aver visto una sua squadra superare un turno di Playoffs.


Arenas, Jamison e Butler.
Almeno si poté risparmiare i tragici eventi del Dicembre 2009. Arenas, che aveva giocato solo quindici partite nelle due stagioni precedenti, tornò in forma per l’annata 2009-2010, giustificando il contratto a 111 milioni in sei anni. Era a 22 di media, compresi i 45 del 18 Dicembre ad Oakland contro il rookie Steph. Ma la data del misfatto è il giorno seguente. Il luogo: l’aereo che portava la squadra a casa dopo la sconfitta sul campo dei Suns. Gilbert Arenas, Javaris Crittenton e diversi altri giocatori erano impegnati in una partita di carte e le cose si scaldarono in fretta. Caron, che durante la fase di atterraggio si era addormentato, aprì di colpo gli occhi quando sentì il Crittenton furente urlare: “Put the money back. Put the fucking money back”. Gilbert rispose che non avrebbe restituito nulla. E quando si mise il malloppo in tasca, Javaris balzò dall’altra parte del tavolo e lo strattonò. Antawn Jamison fece da paciere, ma la cosa non sarebbe finita lì. Butler prende in mano la situazione e chiede a quanto ammontava la posta: circa mille dollari fu la risposta. L’opinione di Caron è chiara in merito: “A man who has a $111 million contract shouldn’t be fighting over $1000”. Ma i due continuarono a discutere, anche scesi dall’aereo. “Vedrò il tuo culo all’allenamento e sai cosa sono capace di fare” disse Gilbert. “Che cazzo dici? Sai cosa faccio… Tirerò fuori la pistola” replicò Javaris. “Bene. Lo farò anch’io” concluse sicuro di sé Agent Zero. Il giorno dopo era di riposo, ma il 21 Dicembre alle 10.00, entrando negli spogliatoi del Verizon Center, a Caron sembrò di essere salito sulla DeLorean. “I thought I had somehow been transported back to my days on the streets of Racine”. Gilbert era in piedi, davanti ai suoi due armadietti (quelli che una volta erano di MJ) con quattro pistole ben in vista. Javaris era di fronte al suo di armadietto, dando le spalle a Gilbert. Fu Hibachi a iniziare: “Hey, motherfuc*er, vieni e prendine una. Ti sparo nelle chiappe con una di queste”. “Oh no – disse Javaris – non hai bisogno di spararmi con una di quelle. Ne ho una anch’io, proprio qui”. E, sempre stando alla versione Butler, come un pistolero si girò lentamente, con il ferro saldo in mano. Gli altri giocatori, che nel frattempo erano sopraggiunti scherzosi, impallidirono. L’unico a non andare nel panico fu Caron, che aveva vissuto cose ben peggiori da ragazzo. “This would have been just another day on the south side”. Parlò con Javaris, mentre lentamente Gilbert lasciò la scena. Anche Javaris abbassò lentamente la pistola. Tutto si concluse così, con la chiamata del compianto Coach Saunders al 911. Concluse, si fa per dire. La NBA fece sapere ai due cowboys che se ne potevano anche andare a giocare al Far West da un’altra parte. Fu un peccato per Arenas, meraviglioso giocatore; molto meno per Crittenton, tuttora detenuto per altre nefandezze. Squadra, progetto e sogni di gloria da buttare.


Fu così che tutti furono, di nuovo, sul punto di partenza. Il rebuilding mode che darà a Washington la prima chiamata assoluta nel Draft 2010 (convertita in John Wall) manda Caron alla corte di Marcus Chabenisky in quel di Dallas. Allenata da quel “genio cestistico” che è Rick Carlisle, la squadra guidata da Dirk Nowitzki e diretta da Jason Kidd ebbe in Caron Butler uno dei più prolifici realizzatori. Nei Playoffs 2010 vennero eliminati a sorpresa dagli Spurs, ma il vulcanico proprietario di origini libanesi non demorde e in estate firma Stojakovic e Brewer, rifirmando Nowitzki e Haywood. Appena arrivato il 2011, però, il ginocchio di Caron cede nella trasferta a Milwaukee (manco a farlo apposta). Non poteva più appoggiare la gamba, ma neanche uscire di scena sconfitto davanti al suo pubblico. Così si fece forza e uscì con le proprie gambe. A fine gara, i compagni gli promisero di arrivare fino in fondo per lui. Dopo l’operazione, partecipò ad ogni sessione d’allenamento, ad ogni partita e fece anche sedute aggiuntive per la riabilitazione. Caron voleva tornare in campo con i compagni. Gli piaceva eh stare a sentire Cuban (“a great opportunity, everybody loved him”), ma voleva partecipare alla cavalcata all’Anello. In sei partite furono battuti i Blazers, in 4 easy i Lakers e in 5 i Thunder. I dottori arrivarono finalmente a dirgli che, se fosse servita una Gara 7 nella finale contro gli Heat dei Big Three, avrebbe potuto giocarla. Non servirà, ma anche Caron riuscì a mettere “le proprio impronte digitali sul trofeo”. Quella notte Cuban portò la squadra al Vivid, uno dei più esclusivi club di Miami, dove lasciò sul piatto dei festeggiamenti circa trecentomila dollari. Non che Caron questa se la sia spiegata.


La sua carriera finì sostanzialmente lì, sul carro che portava i Mavs trionfanti per le strade di Dallas. In realtà farà ancora due stagioni non male con i Clippers (“ora nelle sapienti mani di Doc Rivers e Steve Ballmer”), prima di tornare a casa per giocare con i Bucks. Molla il Winsconsin (“we were tanking from the beginning”) la stagione stessa (2013-2014) quando un ragazzo piuttosto lungo e magro lo chiamò dall’Oklahoma. Di quel ragazzo Butler sapeva già: lo aveva visto giocare già alla Montrose Christian School a Rockville, nel Maryland, mentre lui giocava lì vicino per gli Wizards. Era Kevin Durant, che solo pochi mesi dopo l’arrivo di Butler a OKC venne nominato MVP. Nel celeberrimo discorso di accettazione, The Slim Reaper riporta un aneddoto presente anche in Tuff Juice:
Dopo che avevamo perso 2/3 partite, mi lasciasti un bigliettino nel mio armadietto con scritto KD MVP. Fu molto importante per me, man.
Caron dice di essersi sentito male quando, dopo sette anni, i Thunder licenziarono Coach Brooks: “uno che sapeva ascoltare, non solo parlare”. Ma gli allenatori di quella squadra erano due: l’altro, in campo, era Fish. Che poi intraprenderà la carriera da allenatore, senza risultati esaltanti al momento. Nell’estate 2014 Caron firma un biennale a 10 milioni totali con i Pistons. Il discepolo di Riley, Stan Van Gundy, lo voleva fortemente come mentore per un giovane gruppo di ragazzi. L’anno dopo firma un biennale con i Kings, dove tuttora gioca poco/nulla, costretto a guardare dalla panca le follie (in tutte le sfumature possibili, cestistiche e non) di DeMarcus Cousins.


E’ stata una lunga, difficile scalata dal freddo pavimento della cella di isolamento ad Ethan Allen ai parquet NBA. Sono orgoglioso di essere riuscito in questa scalata, di aver giocato tredici stagioni da professionista con altre a venire, di aver guadagnato abbastanza denaro da rendere la vita più facile e più piena per me e la mia famiglia, e di aver creato migliori condizioni di vita per tutti quelli che abiteranno a Racine dopo di me. Questa è la vita che ho sognato da bambino, ma vivere tutto ciò è stato molto meglio di quello che avrei mai potuto immaginare.
The end. Thank you, Caron.
Michele Pelacci