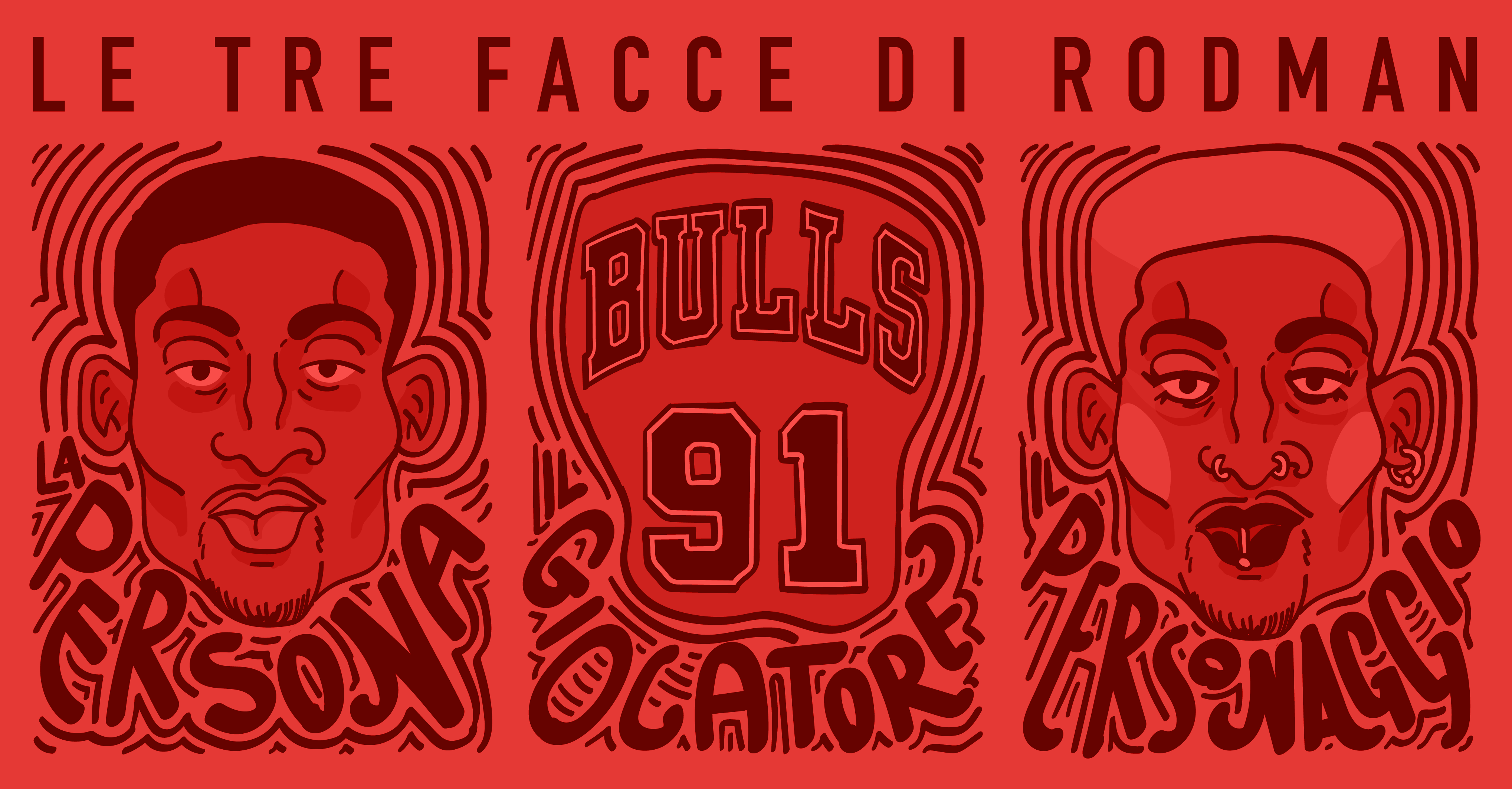pubblicato il 30 Novembre 2015
Ho un’immagine piuttosto netta e definita del preciso momento in cui Kobe Bryant è scivolato dentro la mia personale valigia dei ricordi e delle esperienze. Quella valigia che ognuno di noi si porta dietro, esattamente come un trolley in un terminal, e che dissemina al nostro passaggio una scia, un sentore di ciò che siamo e del perché siamo.
Ecco, Kobe nella mia ci è entrato all’improvviso, un giorno d’autunno del 1997. Un giorno di festa, il compleanno.
Fra i regali, uno su tutti mi rapisce totalmente: forma rettangolare, custodia di plastica lucente, Olajuwon (del quale, all’epoca, ignoravo totalmente l’identità) in copertina, sotto la scritta Playstation, sopra Total NBA ‘98.
Lo scarto subito, curioso, e comincio a giocarci, quand’ecco che lo vedo. È lì nella starting lineup dei Lakers. Numero 8 e quel sorriso stampato in volto. Un sorriso divertito ma beffardo, che è diventato un suo marchio di fabbrica quasi quanto la varietà di pump fakes utilizzate in attacco. Quel ghigno amletico che sembra offrirti amicizia mentre con la mano ti sfila dalla tasca il portafogli. Un’espressione unica che, se Vinci avesse posticipato di mezzo millennio circa la nascita del suo più geniale cittadino, forse oggi troveremmo sul quadro più famoso al mondo.
Con lo sguardo fisso su quella smorfia è iniziata la mia relazione – naturalmente unilaterale – con Kobe.
Un rapporto dalla fisionomia cangiante, costretto ad un’evoluzione multiforme dal tempo e dalle circostanze, fra le quali, soprattutto, Kobe stesso.
Uno sportivo, un uomo dotato tanto di un talento cristallino, quanto di una personalità tanto – forse troppo – ingombrante, che mi ha portato alternativamente ad avvicinarmi e allontanarmi da lui, in una sorta di elastico simile a quello di due ciclisti in fuga solitaria sul Mortirolo.
Si tengono la ruota, grondanti di sudore, si attaccano in una concordia di pedalate, per poi staccarsi e ricominciare tutto daccapo, quasi come in un passo a due. E così è stato anche per me.
Ho ammirato Kobe Bryant.
L’ho guardato, l’ho studiato, sono arrivato persino ad amarlo.
Poi l’eccessiva grandezza e la mia naturale avversione per la stessa mi hanno portato a dissociarmene, distaccarmene, odiarlo, fino addirittura a rinnegarlo. Più volte ho cercato di disfarmi di lui ed estrarlo una volta per tutte da quella valigia, abbandonandolo in aeroporto come quel paio di mutande che vi fa sforare la franchigia per l’imbarco.
Alla fine, però, non ce l’ho fatta. Ha vinto lui, come (quasi) sempre.
E allora, dopo anni, ho smesso di combatter(lo) e ho capito che devo accettarlo così com’è, nudo e crudo.
E proprio a suggello di quest’acquisita consapevolezza ho deciso di scrivere qualche parola, che serva a celebrare Kobe Bryant per quello che effettivamente è: una leggenda vivente.
Definizione, questa, spesso (ab)usata nell’ambito del giornalismo sportivo, ma in questo caso realmente calzante, e anzi doverosa. L’attualità l’impone, ma senza esserne unica giustificazione.
Lo sapete tutti ormai: circa un anno fa Kobe ha strappato a Michael Jordan il gradino più basso del podio dei migliori realizzatori della storia dell’NBA.
Diciannove stagioni e 32mila e rotti ondeggiamenti della retina dopo il grande salto nel mondo dei pro ha raggiunto questo traguardo, condizione necessaria, certamente, ma non sufficiente a fare di lui uno sportivo…
Eh sì, perché l’aver sorpassato il più grande di tutti per numero complessivo di punti segnati sarà pure un risultato importante – anche se, viste le condizioni attuali dei Lakers, forse è più una magra consolazione –, ma certo ascrivere ad esso esclusivamente il merito del conseguimento dello status di immortale fra i mortali sarebbe ingiusto, oltre che riduttivo.
Quello che Kobe Bryant ha rappresentato e rappresenta tutt’ora per l’NBA e il mondo del basket in generale va ben al di là di una manciata – se così si può dire – di canestri e di una serie di record individuali, seppur impressionanti. Al punto che, se avesse deciso di ritirarsi dopo l’infortunio subito nel 2013, sarebbe comunque a mani basse fra i primi 7-8 giocatori più forti di ogni epoca.
E questo è assolutamente innegabile per una serie di fattori e accadimenti, che hanno reso – fino a questo punto – la sua carriera un unicum assoluto.
Anzitutto ci troviamo di fronte ad un giocatore che ricalca i contorni tradizionali del prototipo del vincente, permettendosi tuttavia qua e là qualche deviazione di assoluta singolarità, che non consente di imbrigliarlo appieno all’interno di quel prototipo stesso.
Ciò si coglie benissimo nel suo stile di gioco: coerente, identificabile, definito, ma, al contempo, in evoluzione continua.
Si può infatti affermare, senza correre il pericolo di alcuna smentita, che nel corso di questi 20 anni non abbiamo mai visto un vero e proprio “prime” (come piace dire ai nostri colleghi d’oltreoceano) di questo giocatore, ma ne siamo stati testimoni di almeno quattro versioni differenti.
In primis, sicuramente, il Kobe dell’era Three-Peat (‘96-2002).
Più facilitatore che realizzatore, più Point-Guard che Shooting-Guard. Un giocatore incredibilmente efficiente e al contempo geniale, bello da vedere e coinvolgente.
Un secondo violino 5 stelle extra-lusso con room service di aragosta da 25 punti, 4.9 assist e 5.7 rimbalzi a partita, capace di condizionare in maniera completa qualsiasi difesa, prima con un tiro con mano del difensore a un palmo dal naso, poi trovando il compagno libero con qualche lettura geniale.
Il tutto prima di compiere 24 anni.
Le premesse sembrano condurre ad un certo tipo di giocatore: una guardia tiratrice con il vizio del passaggio. E invece ci ha pensato il Kobe dell’era post-Shaq (2003-2007, con un piccolo arrotondamento) a spazzare via ogni tentativo d’inquadramento.
Una trasformazione degna della Madama Butterfly di Jeremy Irons e David Cronenberg, che ha partorito uno dei più prolifici scorer, che i miei occhi abbiano avuto la fortuna di vedere.
Il tutto messo in scena alla perfezione nella stagione 2005-2006, che resta lì, a imperitura memoria, già pronta alla manzoniana sentenza dei posteri.
Oltre 35 punti di media con il 45% dal campo in 82 partite, scollinando ben 6 volte sopra i 50 punti (solo Chamberlain e Jordan hanno fatto di meglio su stagione singola), di cui una impreziosita da un sovrumano picco di 81 punti.
Un’annata monstre resa ancor più incredibile, se possibile, dalle 45 vittorie, ottenute nonostante il supporting cast di infimo livello formato da: Kwame Brown, Smush Parker, Chris Mihm e un Odom non ancora propriamente LaMarvellous.
Un Kobe così in stato di grazia, che nel vostro ipotetico viaggio a Las Vegas sarebbe quello che sa contare le carte senza farsi sgamare.
Sì, è vero, magari vi fa sedere poco ai tavoli, magari non vincete nemmeno così tanto, però cazzo per qualche mano vi fa assistere al miracolo dell’arte!
Dopo qualche altro paio di stagioni in cui, sostanzialmente, forma in solitaria uno dei primi 10 attacchi della lega, ecco la nuova svolta: l’era Gasol (2008-2013).
Un periodo di maggior maturità e consapevolezza, durante il quale sopprime in larga parte l’istinto primordiale per il canestro, sacrificandolo sull’altare del bene supremo (l’anello) e in favore del compagno che ha sempre desiderato (il Catalano).
L’acquisizione di un gioco molto più perimetrale e un ritorno alla condivisione del pallone gli portano 3 finali, 2 anelli (i più belli forse) e altrettanti MVP.
Una nuova metamorfosi, però, è dietro l’angolo e viene gradualmente scatenata dall’addio del pater familias Phil Jackson, dagli arrivi e le partenze di Mike Brown e D’Antoni, dai litigi con Howard, prima salvatore e poi traditore e, al fine, da un tendine d’Achille che fa “pop”.
Ed ecco, così, il nuovo-vecchio Kobe del Sorpasso (non quello di Dino Risi), sempre più solo e isolato. Impegnato, come cantava Tupac Shakur – altro figlio della costa est che, come lui, ha lasciato un segno profondo nella Città degli Angeli –, in un «Me against the world» apparentemente senza sosta.
In tutto questo percorso così travagliato, policromo e iridescente, fatto di sentimenti contrastanti, amore e odio, critiche e lodi, sia dei singoli che dell’opinione pubblica, si può forse ritrovare una costante.
In questo viaggio, nel corso del quale è stato probabilmente il più forte giocatore della Lega senza tuttavia esserne mai il vero padrone (complice anche la compresenza dei vari Duncan, Iverson, O’Neal, McGrady, che assieme a lui han traghettato l’NBA dall’era-Jordan all’era-LeBron); e ha ottenenuto sicuramente meno riconoscimenti di quelli che avrebbe meritato (fatale, in merito, quella macchia di violenza sessuale, che forse gli ha negato qualche MVP), si può individuare un fil rouge, un trait d’union.
Questo risiede senza dubbio nell’essenza stessa dell’uomo, prima, e dell’atleta, poi, Kobe Bryant.
Un noumeno integralmente votato alla filosofia del «chi s’accontenta, non gode un cazzo», che fa di lui un esemplare sempre più raro nella variegata fauna cestistica attuale, con tutti i pro ed i contro del caso.
Una primadonna assoluta, forse l’ultima vera “Diva” che Hollywood avrà il piacere d’ammirare: talentuosa e bella all’inverosimile, quanto bizzosa, contraddittoria e, a tratti, intrattabile.
Un’attrice che ambisce a vincere l’Oscar ogni anno, lavorando con i migliori registi e il miglior cast di supporto possibile, pretendendo però di essere pagata comunque più di tutti gli altri, perché alla fine è la sua faccia a finire sulla locandina.
Giusto? Sbagliato? Chi può dirlo! Certamente si tratta di un atteggiamento tanto equivoco, quanto – ad oggi – anacronistico, esattamente come il suo modo di continuare a giocare e vivere il Basket.
Un metodo pieno di palloni tenuti fermi, tanti tiri (molti sbagliati), basse percentuali (rispetto a quanto ci aveva abituati), molti minuti sul parquet, guerra aperta con avversari e soprattutto compagni; inefficiente anche, sotto certi punti di vista, ma di una bellezza ammorbante, che conquista proprio perché ormai inusuale.
In un mondo in cui persino le Formula 1 hanno un’alimentazione ibrida per aumentare al massimo l’efficienza, lui è una Porsche degli anni ’70. Non ha moltissimi cavalli, beve come Gascoigne, ma il rumore che fa, quando entra la coppia e si passano i tremila giri, è il Koh-i-Noor: un diamante senza prezzo.
Tutto ciò si carpisce guardando l’azione che l’ha visto protagonista un annetto fa contro i Raptors e Terrence Ross.
Qui c’è tutto Kobe.
In quello sguardo di sfida all’arbitro c’è Tupac Shakur: «It wasn’t nuttin’ like the game, it’s just me against the world».
Nella scelta di non prendere un tiro con spazio e di aspettare il difensore per umiliarlo c’è la scintilla primigenia dello sport – che vive in lui più forte che mai – come affermazione di sé e prevaricazione sull’avversario. I due punti in crossover con step-back sono il Prestigio, il tratto distintivo della Star, la smorfia di De Niro, il neo sopra il labbro superiore della Monroe.
Il clamore e i cori della folla solamente il giusto tributo a cotanta magnificenza.
Incredibile come in pochi secondi sia racchiuso tutto quello che, effettivamente, è Kobe Bryant: un campione con pochi limiti e senza confini, ultimo esemplare di un modo di intendere ed interpretare la pallacanestro, che ormai non esiste più. Un istinto a dare tutto, sempre e comunque, senza compromessi, che è stato risucchiato dalla generale tendenza a gestirsi, risparmiarsi.
«Grande spirito e creatore della vita, un Guerriero va a te veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. Dà lui il benvenuto e lascia lui prendere posto in Gran Consiglio di mio popolo. È Uncas, mio figlio. Dì lui di essere paziente e dà a me una rapida morte, perché loro sono tutti là. Meno uno, io: Chingachgook, l’Ultimo dei Mohicani».
Così parlò Russell Means in un famoso film del 1992.
Ma Kobe no.
Kobe è hic et nunc, qui e ora. E come diceva, ancora, Tupac: «A coward dies a thousand times, a soldier but once/Un codardo muore mille volte, un guerriero solo una».
E il turno di Kobe Bryant non è ancora arrivato.
Mettetevi l’animo in pace.