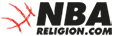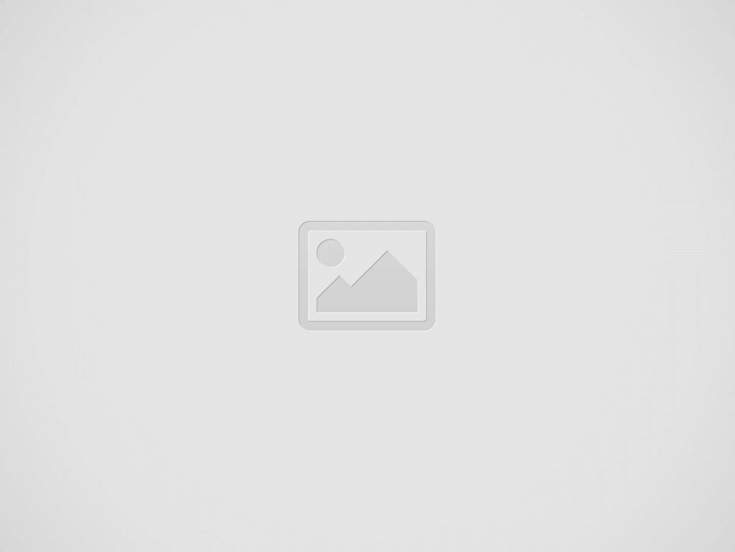

Nel terzo episodio di NBA Wars: Nike vs. Adidas (potete ritrovare i precedenti capitoli cliccando su ciascuno di questi numeri: I°, II°, III°) abbiamo visto la caduta e la risalita del brand tedesco, grazie a due uomini chiave che precedentemente lavoravano per lo Swoosh: Peter Moore e Rob Strasser. La prematura scomparsa di quest’ultimo non ha però rallentato la ripresa di Adidas, che è riuscita a tornare sulla retta via, almeno per quanto riguarda il mercato delle scarpe da basket, soprattutto grazie all’arrivo di un giovanissimo Kobe Bryant.
In questo, conclusivo, episodio della serie Nike vs. Adidas, vediamo dunque nel dettaglio come l’azienda delle tre strisce sia stata capace di mettere sotto contratto un giocatore così importante, nonostante i suoi ben noti problemi societari. Sarà necessaria una figura altrettanto importante, della quale abbiamo già avuto modo di parlare, e che nel 2003 proverà a portare in Adidas anche un diciottenne LeBron James. Per capire cosa sia stato svolto con successo e cosa no, però, bisogna partire dall’inizio e, più precisamente, dal campus della Fairleigh Dickinson University, nel New Jersey, nel luglio del 1994.
“L’ABCD Camp era conosciuto come la migliore vetrina per giovani talenti provenienti dalle high school di tutti gli Stati Uniti. Quell’estate, Joe Bryant si presentò al camp – viveva a Philadelphia, ma in quel momento si trovava nel New Jersey. Chiese di me, e quando mi trovò mi disse semplicemente: ‘Puoi fare in modo che mio figlio partecipi al tuo camp?’ Non vedevo Joe o sua moglie Pam dal 1972; non sapevo nemmeno avessero avuto un figlio. Non sapevo nulla di Kobe Bryant, così come il resto del mondo, perché fino a quel momento aveva vissuto in Italia, e quando lo incontrai per la prima volta stava per cominciare il suo anno da junior alla Lower Merion High School, in Pennsylvania.”
“Lo feci entrare in campo, dove quell’anno avremmo avuto otto futuri NBA All-Star: da semplice sconosciuto chiuse il torneo entrando nell’All-Star Team dei junior. Kobe corse da me, mi abbracciò e mi disse: ‘Grazie, signor Vaccaro, per avermi invitato all’ABCD. Mi dispiace averla delusa’. Io risposi: ‘Kobe, sei entrato nel Team degli All-Star’. Se entravi in quel team significava che avresti avuto un grande futuro. E lui mi disse: ‘L’anno prossimo sarò il giocatore migliore del camp’.”
A parlare è Sonny Vaccaro, intervistato lo scorso gennaio, poco dopo la prematura scomparsa della leggenda dei Lakers. Con la voce rotta, ricorda con piacere quell’episodio. Ricorda molto bene anche l’edizione dell’anno successivo di quel camp, quella del 1995, dove effettivamente Kobe Bryant fu l’MVP della manifestazione, nonostante i 17 anni ancora da compiere. Tanto che Sonny gli propose immediatamente di firmare per l’azienda per la quale lavorava all’epoca: Adidas.
Scommettere tutto, mettersi in gioco
Sì, Adidas: perché fra il 1984 e il 1995 le cose sono cambiate parecchio. Non solo per il benservito di Rob Strasser e Peter Moore a Nike, ma anche per quello di Sonny Vaccaro. Sonny è sempre stato uno spirito libero, e come tale non vuole affiliare il suo nome a quello di un’azienda per troppo tempo. In effetti, prima del 1991 e in particolare dopo l’arrivo di Michael Jordan a Nike, chiunque avesse contatti con Sonny vedeva in lui l’espressione di quel brand. Con l’abbandono di Strasser e Moore, però, Vaccaro capisce che non è questo ciò che vuole, e proprio nel 1991 saluta il team di Phil Knight, prepara le valigie e prende un volo diretto verso la sua indipendenza, che assume il nome di New Jersey. Ritrovata la sua dimensione, dedica anima e corpo allo sviluppo di quel torneo, l’ABCD Camp, che si svolge esattamente nel New Jersey e che in breve tempo soppianta il Dapper Dan Roundball Classic Tournament, diventando il punto di riferimento per i giocatori delle high school che volessero mettersi in mostra.
Non solo: considerando l’esperienza Nike completamente archiviata, a partire dal 1992 Vaccaro inizia a collaborare con Adidas, seppur da “elemento esterno”, indipendente, per la quale svolge lo stesso ruolo ricoperto in precedenza per l’azienda rivale: scovare talenti e trovare nuovi accordi di sponsorizzazione. Proprio Adidas, a partire da quell’anno, sponsorizzerà il Camp, portando ulteriori risorse per dare la caccia ai migliori prospetti in circolazione. È così che avviene il primo incontro fra Joe Bryant e Sonny Vaccaro, poi quello fra Kobe Bryant e il fondatore del torneo, così come descritto dallo stesso Sonny nell’intervista riportata poco fa. Come già successo con Michael Jordan, per quest’ultimo sarà amore a prima vista.
“Con Adidas avevamo alcuni buoni atleti sotto contratto, ma volevamo fare quello che Nike fece con Michael Jordan. Nike e le altre aziende in cerca di nuovi giocatori da sponsorizzare non volevano avere a che fare con un ragazzo della high school. Ma sapevo che volevamo Kobe più di ogni altra cosa, e per questo gli proposi un accordo con i fiocchi.”
“Kobe è stato, per me, il Michael Jordan di Adidas, ma c’era una differenza. Con Nike avevamo già una solida base dalla quale partire per offrire tutti quei soldi a Mike. Avevamo sponsorizzazioni con molti college della NCAA, tutte le quattro squadre della Final Four del 1983 calzavano lo Swoosh. Insomma, Nike era stabile, e se il progetto Michael Jordan fosse fallito l’azienda sarebbe comunque rimasta in piedi senza particolari problemi. Dodici anni dopo, Adidas non aveva nessuno, e stavamo sostanzialmente scommettendo tutto quello che avevamo su Kobe. Non potevamo sbagliare, e non l’abbiamo fatto. Kobe cominciò la sua carriera con Adidas e, per questo, l’azienda tornò a essere affidabile per i giocatori di basket.”
Sonny Vaccaro è dunque pronto a scommettere tutto, a rimettersi in gioco. Nel maggio 1996, quindi, prima ancora che venga selezionato al Draft NBA, il ragazzino prodigio di diciassette anni ha già un accordo multimilionario con il brand tedesco. Sia il giocatore, che Sonny, che l’azienda si dicono soddisfatti: in fondo, Kobe è un giocatore dal potenziale enorme, viene pagato relativamente poco se confrontato alle Star degli anni ’90, e avrà tutto il tempo di dimostrare il suo valore, per poi portare pubblicità al marchio.
Sonny Vaccaro, però, non si ferma qui. Passa un solo anno e si innamora di nuovo, questa volta di un giovane talento originario della Florida. È estate 1996 quando, sempre all’ABCD Camp, fa ingresso in campo un ragazzino assolutamente sconosciuto, di nome Tracy McGrady. È più piccolo e più giovane rispetto agli altri partecipanti – Elton Brand e Al Harrington su tutti. Nonostante questo, McGrady si ritaglia gradualmente uno spazio a quel torneo, e di conseguenza attira anche gli sguardi di diversi scout NBA e, soprattutto, di Vaccaro. Alla partita conclusiva del torneo ruba palla a metà campo, per involarsi verso il canestro avversario, posterizzando il malcapitato James Felton. È il colpo di fulmine: il fondatore del torneo propone a McGrady di firmare per Adidas, sulla base di un contratto da 1,7 milioni di dollari l’anno. Il giovane giocatore, che nel frattempo da sconosciuto quale era è diventato uno dei migliori prospetti degli Stati Uniti, accetta senza pensarci due volte.
“Sono grato a quelle persone che hanno visto qualcosa in me e hanno creduto in me, anche se forse io stesso non l’ho fatto. Ho partecipato a quel camp con la maglia numero 175 [quella che veniva assegnata all’ultimo giocatore selezionato per partecipare al torneo, ndr]. Nessuno aveva la minima idea di chi fosse Tracy McGrady. Mi avete dato un’opportunità, e io ho potuto competere contro i migliori giocatori del mondo in quel momento. E ho lasciato il camp da giocatore numero uno della nazione” — Tracy McGrady, rivolgendosi a Sonny Vaccaro, in occasione del discorso della sua induzione nella Hall of Fame, l’8 settembre 2017.
Con due firme così promettenti, Adidas è pronta a riprendere quello che aveva dovuto interrompere sul finire degli anni’80: il dominio delle sponsorizzazioni in NBA. In effetti, a cavallo fra gli anni ’90 e 2000 l’azienda tedesca darà parecchio filo da torcere alla rivale. Nel 1997, Kobe Bryant riceve il suo primo paio di signature shoes, le Adidas KB8, che diventeranno in seguito conosciute anche come Crazy 8s per lo stile originale di colori e forme. Proprio nella stagione 1997-98, il numero 8 dei Lakers, calzando un paio delle sue nuove player’s edition, ha modo di affrontare il suo idolo Michael Jordan, che invece indossa le Air Jordan. Sull’onda dell’entusiasmo di quelle nuove scarpe, ad alcuni spettatori sembra che a scontrarsi non siano solo il presente e il futuro della pallacanestro, ma anche la storia delle scarpe da basket.
Kobe Bryant contro Michael Jordan, in una partita della stagione 1997-98. Il primo indossa un paio di “Crazy 8”, mentre il secondo un paio di Air Jordan (Credits to cokenoice.com)
Adidas comincia a prenderci gusto con i suoi design innovativi e futuristici. Forse addirittura troppo. Nel corso dei playoff del 2000, l’azienda tedesca lancia le Kobe. Vengono prodotte in collaborazione con un’altra importante multinazionale tedesca, Audi, il cui fiore all’occhiello, l’Audi TT Roadster funge da ispirazione per quel modello. Il problema è che la scarpa sembra tutt’altro che una calzatura: non ha lacci, è di un solo colore e ha una forma inusualmente rettangolare.
Si tratta di un errore madornale del marchio tedesco, forse inconsapevole, ma comunque decisivo, poiché sarà l’inizio della fine dell’accordo fra Kobe e l’azienda. Tanto che Adidas, per non farsi mancare niente, ci casca nuovamente. Pur con tutte le buone intenzioni del caso, infatti, la partnership non si rivelerà assolutamente profittevole: le Kobe II, create solamente l’anno successivo per mettere una pezza al precedente modello, sono, se possibile, ancora più discutibili. Disponibili in tre colori (argento, bianco, nero), più che scarpe sembrano due astronavi. Non vendono, e il giocatore che avrebbe dovuto indossarle sostanzialmente si rifiuta di farlo. Addirittura, dopo il lancio, la Star dei Lakers preferisce tornare a indossare il modello precedente. Poco importa se dal 2000 al 2002 Kobe conduce, insieme a Shaquille O’Neal, a tre titoli consecutivi i Lakers. Bryant comincia a guardarsi attorno, e nota che molti giocatori di spicco indossano Nike o, al limite, Reebok, e comincia a pensare ad altro. Si verifica quello che un po’ succede per la fine di una relazione molto intensa: dopo aver viaggiato a velocità piuttosto sostenuta, accade qualcosa di ben preciso, un’insegna ben illuminata segnala l’arresto del viaggio, e non si può più tornare indietro. Bisogna scendere dal treno.
Adidas avrebbe potuto dedicargli tutte le attenzioni del caso, ma ormai il danno era stato fatto, e non c’è più pezza che tenga. Quello che era cominciato come un idillio, tanto da sembrare un matrimonio perfetto, finisce dunque come il peggiore degli amori: divorzio immediato, decisione presa unilateralmente.
Dopo aver indossato Adidas per i primi sei anni della sua carriera, Bryant paga di tasca sua gli oltre 8 milioni di dollari previsti per la rescissione del contratto. Lo stesso accordo prevede che Kobe rimanga un intero anno senza nuovi sponsor: è l’occasione per provare qualsiasi scarpa possibile, per capire quale sia l’azienda migliore per lui, durante la stagione 2002-03: Nike Air Force, Reebok Questions, Converse Weapon. Qualsiasi scarpa non porti il nome Adidas. Finirà con il firmare per Nike, l’eterna rivale, sulla base di un contratto da 40 milioni complessivi su cinque anni. Sostanzialmente, ora lo Swoosh ha tutto il talento possibile in NBA. Nonostante questo, Adidas non può ancora definirsi fuori dai giochi.
The Chosen One
È un soleggiato sabato pomeriggio del maggio 2003 al quartier generale di Nike, a Beaverton, in Oregon. Gli uffici sono vuoti, mentre nel parco adiacente, lo stesso in cui Michael Jordan camminò in compagnia di Rob Strasser e Sonny Vaccaro vent’anni prima, il silenzio regna sovrano. Eppure, nei giorni precedenti, proprio in quei luoghi ora deserti, decine di designer e direttori hanno lavorato senza sosta a dei preparativi degni di un evento regale.
Tecnici ed elettricisti hanno eseguito speciali lavori sulla porta della hall principale, in modo tale che aprendola si avviino automaticamente dei messaggi personalizzati di benvenuto, insieme a diverse visualizzazioni del logo societario, proiettati sulle pareti vicine. Oltre la hall, alcuni impiegati hanno posizionato su entrambi i lati di un lungo corridoio diverse scatole, ognuna delle quali contenente le sneakers Nike rese iconiche da alcune delle Star più famose della NBA: le Air Jordan, le Barkley, le Pippen, le Penny. Seguendo con gli occhi quelle scatole, si arriva in fondo al corridoio, dove al centro, contro la parete, si trova una scatola illuminata da una luce proveniente dall’alto. Solo che è vuota, senza alcuna scarpa al suo interno.
Alla sinistra di quella scatola vuota, un corridoio più breve conduce a una sala conferenze, dove ogni oggetto possibile porta il nome dell’ospite che di lì a breve sarebbe arrivato: zaini, occhiali da sole, pantaloncini, addirittura costumi da bagno. E se il tanto atteso ospite avesse fame, un pacco di Fruity Pebbles sarebbe lì, pronto ad aspettarlo, perché qualcuno, in qualche modo, ha scoperto che è la sua marca di cereali preferita.
Chi è la persona che il team Nike sta aspettando, e per la quale si è dato così tanto da fare? È un diciottenne originario di Akron, di nome LeBron James, che ha deciso di saltare il college per dichiararsi direttamente eleggibile per l’NBA. È uno dei giocatori con il più alto potenziale di sempre, tanto che Sports Illustrated lo soprannomina The Choosen One. Ottenere la sua firma su un contratto di sponsorizzazioni, dunque, significa avere future entrate certe.
Per fare colpo su LeBron, Nike deve assicurarsi che tutti questi dettagli vadano per il verso giusto. Perché James è anche la priorità di Adidas. Non solo la sua, a dire il vero: ad aggiungersi alla lista dei pretendenti, infatti, c’è anche Reebok, un brand che è cresciuto moltissimo negli anni recenti, grazie a Star come Allen Iverson e al fatto di essere, insieme a Nike, l’azienda fornitrice delle divise ufficiali da gioco della NBA.
Proprio per questo, Aaron Goodwin, agente di LeBron, ha programmato tre incontri con le principali case produttrici di scarpe da basket dei primi anni 2000. Reebok per prima, poi Adidas, infine Nike. È questo l’ordine stabilito da Goodwin, desideroso di finalizzare un accordo prima ancora della Draft Lottery, talmente è sicuro delle potenzialità del suo cliente.
LeBron James seduto in panchina durante la sfida contro la Oak Hill High School, il 12 dicembre 2002. In quella partita segna 31 punti, portando la sua squadra alla vittoria contro quella che era la scuola al primo posto nel rank degli interi Stati Uniti. La partita fu di portata talmente grande che ESPN coprì in diretta nazionale l’evento. (Credits to usatoday.com)
“Sentivo come se il mercato e le possibilità di LeBron non sarebbero state decise in base a dove avrebbe giocato, ma a come avrebbe giocato e a come il suo brand si sarebbe evoluto” ricorderà l’agente in un’intervista ad Aaron Dodson del 2018. “Che si trattasse dei Cavaliers o dei Kings non avrebbe fatto alcuna differenza: lui avrebbe fatto la differenza per qualsiasi azienda.”
James, per prima cosa, fa dunque tappa a Canton, in Massachusetts, dove ha sede il quartiere generale di Reebok, insieme al suo agente e a sua madre Gloria. In quel primo incontro, per buona parte della giornata la stella St. Vincent-St. Mary non fa altro che ascoltare un esaustivo spiegone sulle mosse di marketing dell’azienda e sulle attenzioni che il brand è pronto a dedicargli. Terminato l’incontro con i top manager, i designer migliori del marchio lo portano in un’altra stanza, dove gli mostrano oltre 50 loghi ispirati a lui e 10 possibili signature shoes diverse.
“Stavamo provando a dimostrare che eravamo un’azienda pronta a dargli tutte le attenzioni che voleva” dirà Todd Krinsky, presidente della divisione RBK, a The Undefeated. “Non avevamo 1.000 giocatori sotto contratto, quindi era una grande opportunità per poter lavorare con un brand che lo avrebbe davvero reso una priorità.”
All’incontro è presente anche l’amministratore delegato di Reebok, Paul Fireman. È un uomo molto espressivo e teatrale, e possiede una mentalità competitiva e concentrata sul vincere ad ogni costo qualsiasi sfida. Nel 1996 convinse Allen Iverson, prima scelta assoluta del Draft di quell’anno, a firmare per la sua azienda e ora, da Star affermata quale è diventata, è il volto di Reebok.
Proprio per questo, Fireman è molto ansioso, quasi ossessionato dall’idea di poter mettere le mani su un’altra prima scelta assoluta dalle potenzialità almeno pari a quelle di AI: era disposto a pagare più di ogni altro pur di aver LeBron James per sé. Cosa che effettivamente prova a fare, conducendo il giocatore, sua madre e il suo agente in un ufficio privato, dove compila un assegno proprio di fronte a loro. Il trio può uscire con quell’assegno in tasca dagli uffici dell’azienda, a condizione che LeBron firmi con Reebok e che dia la sua parola sul fatto che non avrebbe intavolato negoziazioni con Adidas e con Nike.
“Ero letteralmente senza parole. Si trattava di un assegno da 10 milioni di dollari”, dirà James in un’intervista del 2017 con Uninterrupted.
“Ricordo di aver preso in mano l’assegno, per poi consegnarlo a LeBron”, ricorderà invece Goodwin. “Lui e sua mamma lo guardavano senza fiatare, e gli occhi di Gloria erano lucidi. È stato un momento molto emozionante: tutto ciò per cui avevano lavorato e vissuto stava finalmente accadendo.”
Eppure LeBron fa una scelta da uomo adulto, nonostante i suoi 18 anni:
“LeBron capì che avrebbe dovuto dare indietro l’assegno a Paul Fireman. Gloria non voleva, desiderava tenere quell’assegno e uscire dagli uffici. Ma anche con quella offerta, LeBron sapeva che prima avrebbe dovuto parlare con Adidas, e stare a sentire anche cosa avesse da offrire Nike, per poi prendere una decisione successivamente.”
La compagnia di James prende dunque un volo in direzione Malibu, California, dove Adidas ha addirittura preso in affitto una villa per mostrare la propria visione al futuro giocatore dei Cleveland Cavaliers. Ad aspettarlo, insieme a David Bond e altri top manager del brand tedesco, c’è ovviamente Sonny Vaccaro. I due uomini hanno trascorso l’ultimo anno e mezzo lavorando esclusivamente su una strategia che potesse convincere il giocatore degli Irish a firmare per loro. I due sospettano che gli impiegati Nike diranno a James che accordandosi con loro diventerà il nuovo Michael Jordan. Vaccaro e Bond, invece vogliono proporre qualcosa di più: usando il paragone di Muhammad Ali, vogliono far passare il messaggio che con Adidas lui potrebbe diventare molto più di un semplice atleta. Non avrebbe semplicemente rappresentato la pallacanestro, ma si sarebbe impegnato anche per importanti questioni sociali. Non c’è solamente questo ad aspettarlo. Ovviamente c’è anche un’offerta monstre sul tavolo: 100 milioni di dollari complessivi in 10 anni, ovvero 10 milioni l’anno. Nonostante ciò, il giorno della presentazione, le gambe dei dirigenti Adidas tremano. Le negoziazioni sono un gioco di nervi saldi e sangue freddo e, evidentemente, il brand tedesco non ha ancora imparato dai suoi errori.
“Ci eravamo accordati in anticipo sulla proposta finale: 100 milioni di dollari, tutti garantiti”, ricorderà David Bond a The Undefeated. “All’ultimo secondo, però, l’amministratore delegato [all’epoca Herbert Hainer, ndr] cominciò a titubare. Non era sicuro al 100% che l’impatto di LeBron sarebbe valso tutti quei soldi. In quel momento non conoscevamo ancora l’offerta di Nike o di Reebok, ma non appena facemmo scorrere il foglio con l’offerta dall’altro lato del tavolo, come loro videro la cifra sul foglio capimmo che era già finita. Faceva schifo, a dirla tutta. Non ci sono secondi posti in questo gioco di negoziazioni. O vinci o perdi, e noi abbiamo perso.”
Senza che Bond e Vaccaro ne abbiano notizia, l’offerta finale è infatti scesa dai 10 milioni l’anno previsti a 7 milioni. Vaccaro si sente talmente tanto preso in giro da rassegnare le dimissioni, quasi seduta stante, passando a lavorare per Reebok fino al 2007, anno in cui andrà in pensione.
Il terzo incontro, infine, vede LeBron in Oregon, in quegli uffici Nike allestiti di tutto punto per l’occasione. Non appena arriva a Beaverton, l’edificio si ripopola di sorrisi smaglianti e fiduciose strette di mano. James, aprendo la porta della hall principale, vedrà i video di benvenuto proiettati sulle parenti; vedrà le scatole con le storiche Nike del suo idolo Michael Jordan, di Scottie Pippen e di Charles Barkley. In fondo a quel corridoio vedrà la scatola vuota, illuminata da un solo fascio di luce, pronta ad accogliere le sue personali signature shoes; infine, nella stanza adiacente noterà tutti i gadget personalizzati.
“Nike è il giusto fit e ha il prodotto più adatto a me nel momento più giusto”, dirà James il 22 maggio 2003, il giorno in cui firma una lettera di intenti con lo Swoosh. “Sono un’ottima compagnia che sarà impegnata a supportarmi nella mia carriera professionale, dentro e fuori dai campi da basket.”
Nel 1984, Nike offrì 2,5 milioni di dollari a Michael Jordan in cinque anni. Nel 1996, Iverson firmò con Reebok per 50 milioni di dollari complessivi spalmati su 10 anni. Nel 1997, Adidas convinse Bryant con 5 milioni di dollari, assicurandosi anche Tracy McGrady per 12 milioni in 6 anni. Prima ancora di giocare una singola partita NBA, James ha dunque raggiunto uno degli accordi di sponsorizzazione più remunerativi della storia della pallacanestro: 90 milioni di dollari in 7 anni, più un bonus alla firma di 10 milioni di dollari. La stessa cifra che Adidas aveva inizialmente intenzione di offrire. Forse, se l’azienda tedesca si fosse mantenuta su quei numeri sin dall’inizio, le cose sarebbero potute andare diversamente.
Nemici giurati
In ogni caso, Adidas perde due occasioni d’oro nel giro di appena un anno. La storia sembra ripetersi, in un eterno ritorno dai contorni nietzschiani. Il racconto di Michael Jordan, quello di Kobe Bryant e quello di Rob Strasser sembrano non aver insegnato nulla al brand tedesco: Adidas sembra avere il potere di auto sabotarsi nei momenti chiave della sua storia.
I manager capiscono la gravità dell’ennesima scelta sbagliata quando LeBron James vincerà il premio di Rookie Of the Year; e se con il brand tedesco sono comunque rimasti diversi giocatori All-Star, su tutti Tracy McGrady e Gilbert Arenas, questi non hanno lo stesso impatto mediatico degli atleti firmati da Nike. Comprendono allora che, a questo punto, battere la rivale cercando di firmare “il nuovo Michael Jordan” potrebbe essere impossibile, perché lo Swoosh è ormai leader del mercato delle sneakers da quasi 20 anni, e Adidas ha ormai perso troppi treni. Un po’ come due colleghi che non si sopportano, bisogna allora provare a convivere con i propri nemici e ritagliarsi uno spazio parallelo che l’altro non può intaccare. Incredibilmente, l’occasione si presenterà da lì a poco.
Come abbiamo già accennato in precedenza, nel 2003 ci sono solamente due aziende autorizzate dalla NBA per la produzione e la distribuzione delle divise ufficiali da gioco: Reebok e Nike. La prima ha firmato un accordo di esclusiva nel 2001, con effetto a partire dalla stagione 2004-05, secondo il quale Reebok diventerà l’unico distributore e produttore delle uniformi, una volta scaduto il contratto di Nike, per l’appunto nel 2004. È proprio questa l’occasione di Adidas: nel 2005, il marchio tedesco assorbe le attività della società inglese, con un’operazione di acquisizione valutata 3,8 miliardi di dollari, rendendola una sussidiaria, ma di fatto lasciandole piena libertà operativa. È una mossa molto astuta, perché dall’anno seguente di fatto Adidas sostituisce Reebok nella produzione delle divise da gioco, e lo sarà fino al termine della stagione 2016-17. Non solo: con l’acquisizione del marchio inglese, la multinazionale tedesca incrementa il suo giro di affari per le operazioni inerenti alla pallacanestro per un valore complessivo di 11,5 miliardi di dollari. Quello di Nike viene valutato 16 miliardi.
Negli anni più recenti, dunque, la rivalità fra le due multinazionali si è fatta più intensa che mai. L’ambiente NBA è cambiato molto da quando Converse dominava incontrastata, e se ora numerosi fornitori di scarpe sono presenti nella lega il merito è soprattutto di Nike e Adidas, che hanno sempre saputo innovare le loro proposte, sperimentando in campi del tutto nuovi e spesso incappando in errori anche piuttosto grossolani. I colpi di scena non mancheranno mai: gli esempi più recenti sono la firma di James Harden con le tre strisce (per un accordo record da 200 milioni di dollari complessivi) e il ritorno di Nike come fornitrice ufficiale delle uniformi NBA dalla stagione 2017-18. In mezzo a tante discussioni, molte mosse talvolta spregiudicate (le divise a mezza manica di Adidas lanciate dal 2013 e mai più prodotte da Nike, o gli sponsor di terze parti sulle canotte introdotti dallo Swoosh) hanno saputo spostare sempre più in alto l’asticella dell’innovazione.
Sicuramente, senza di loro staremmo parlando di una lega completamente diversa. Quello che NBA Wars: Nike vs. Adidas ci ha insegnato, dunque, è che non bisogna mai smettere di cercare di migliorarsi, per spingere anche i rivali a fare di meglio, pur con tutti i problemi societari del caso: a beneficiarne ci sono entrambi, e il mondo NBA intero. Proprio per questo, se nelle rivalità più spietate spesso non c’è spazio per il fair play, per la correttezza, Adidas e Nike hanno dimostrato di rispettarsi vicendevolmente, consapevoli del loro ruolo nel mondo dello sport. Perché se il fatto che Adidas condivida un video di Nike su Twitter, a sottolineare il bisogno di unità in un momento così difficile per tutti, possa apparentemente significare nulla, dietro ad esso si nasconde tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora: consapevolezza della propria forza, rispetto per il rivale e unità per un obiettivo comune più grande.
I Boston Celtics arrivano all’appuntamento più importante della loro stagione leggermente più riposati e da…
L’attesa è finita. Si alza il sipario sui Playoff NBA e le prime due squadre…
Definire alcuni di loro Rising Stars è già riduttivo. Futuro NBA in ottime mani
Un assistente promosso ad interim prenderà il posto dell’allenatore più vincente nella storia della squadra.
Incredibile epilogo tra Lakers e Chicago con la bomba da oltre metà campo di Giddey
NBA e FIBA hanno confermato lo sviluppo di una Lega europea in collaborazione
Il nativo di Akron ha trascinato i suoi alla vittoria con un tiro a fil…
Il giocatore di Phoenix al centro delle attenzioni di mercato
Il giocatore di Milwaukee con problemi di coagulo, rimarrà fuori per diverse settimane