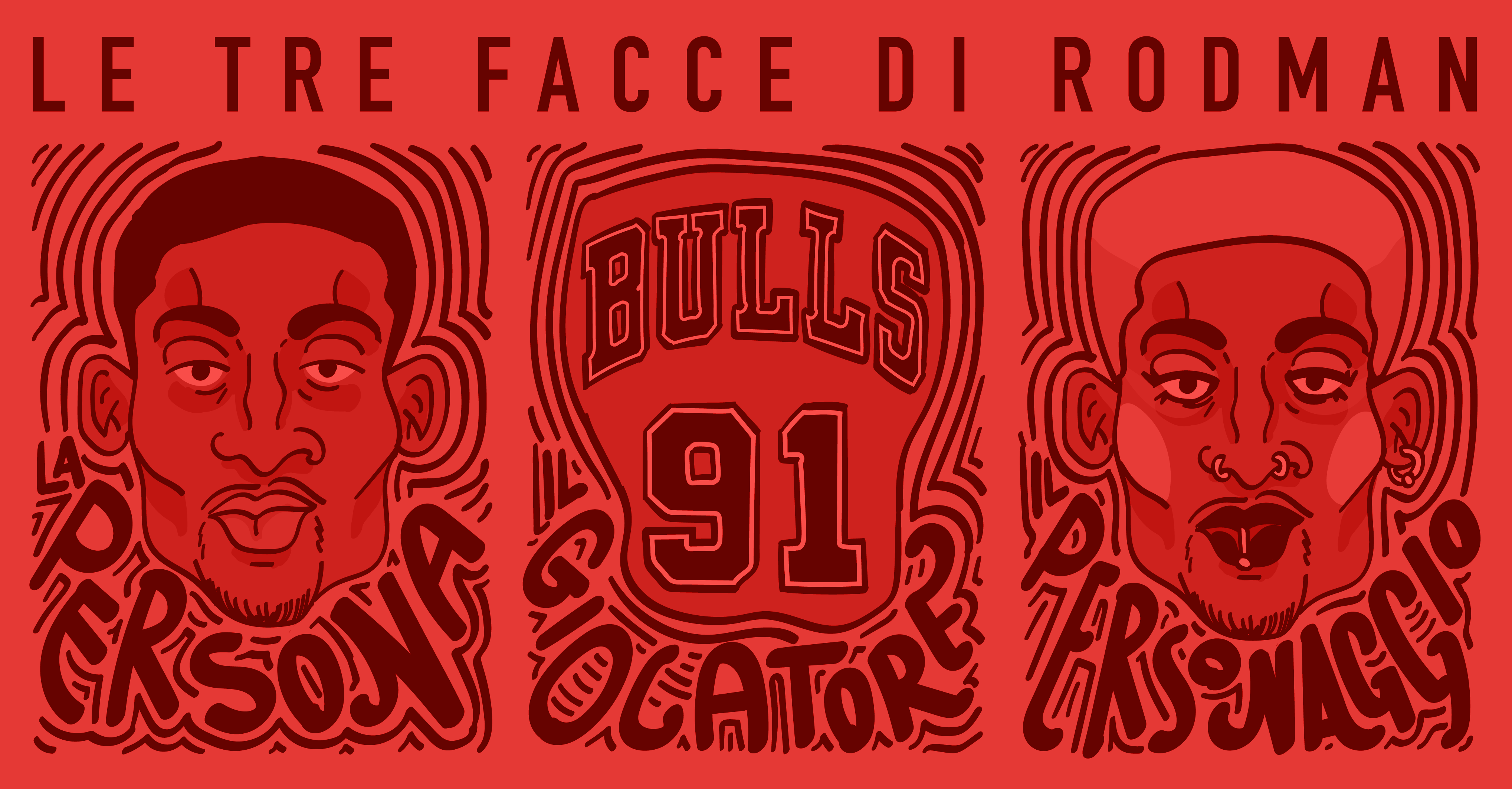Se vi dovesse capitare di trovarvi nei paraggi di un playground in una qualsiasi città americana (in particolare però in una delle grandi Mecche della pallacanestro dell’East Coast, e ancora più in particolare nella più importante di esse, e non occorre specificare quale sia), che siate lì per assistere allo spettacolo del basket di strada o per provare a farne parte, potreste avere la fortuna di sentire qualcuno chiamare a raccolta più persone possibili, gridando a destra e a manca: “He got game! Man, he got game!!”. Quest’espressione, sostanzialmente intraducibile, viene usata infatti quando a giocare c’è qualcuno di veramente forte, che spacca la partita con la facilità con cui Sheed pigliava tecnico; non importa che costui sia Durant capitato al Rucker durante l’off season o un perfetto signor nessuno, conta quello che fa in campo e in quel momento, evidentemente, chiunque egli sia “ha il gioco” (traduzione letterale e brutta quanto un libero di DeAndre Jordan), possiede cioè un innato feeling per questo sport e lo mette in pratica divinamente.
Quest’espressione gergale, nata nei quartieri afroamericani di New York (ovviamente la Mecca di cui sopra), si diffuse velocemente circa quindici anni fa, quando proprio un figlio di Brooklyn la portò alla ribalta mondiale con un film omonimo. Erano dieci anni che Spike Lee, regista originario di Atlanta ma newyorkese al 101%, voleva fare un film di natura sportiva, e ne nacque una bella storia di basket ma anche di rapporti familiari complicati e di denuncia contro l’ipocrisia che circonda questi ragazzi baciati da un talento straordinario. Scritturati subito Denzel Washington nel ruolo del padre e Rosario Dawson in quello della fidanzata, mancava il protagonista, Jesus Shuttlesworth, al quale il nostro regista voleva fortemente dare il volto non di un attore, ma di un giovane giocatore emergente, per una maggiore veridicità. La prima scelta era la stessa dei Sixers nel Draft del 1996: Allen Iverson, che in effetti entrava a pennello nella parte. Ma la Risposta fu negativa, e il ruolo andò a un altro giovane della Draft Class ’96 dal talento se non uguale, di poco inferiore, quel Ray Allen che da lì in poi rimase per tutti, appunto, He got game.
Comprensibile l’idea di Lee: alzi la mano chi non si è mai emozionato nel vedere il piccolo Davide Iverson combattere e sconfiggere i vari Golia della Lega, incarnazione di personaggio e giocatore che non poteva non entusiasmare, anche con tutti i suoi difetti. Pur con l’unanime riconoscimento del suo valore, meno attenzione mediatica ha avuto invece Allen (il cognome di Ray, non il nome di Iverson), forse anche perché la sua taglia fisica era perfetta per il suo ruolo di shooting guard. E che shooting: Jesus nostro sa segnare anche in avvicinamento, in arresto e tiro o addirittura attaccando il ferro se la difesa sta troppo incollata, ma la sua arma migliore è un tiro da tre punti in uscita dai blocchi tanto efficace quanto stilisticamente perfetto (non è così scontato che le due cose coincidano, suonare al campanello “Martin, Kevin”). Un tiro così persino l’altro talentuosissimo Allen (il nome di Iverson, non il cognome di Ray) può solo invidiarlo.
Al momento del Draft, anno di grazia come detto 1996, anche il nostro Ray non poté sfuggire all’orribile usanza americana di paragonare i neo-pro con altri veterani dalle caratteristiche simili, spesso forzandone qualità e attitudini, arrivando a generare non di rado vere e proprie mostruosità (una per tutti, la nidiata dei “Baby Shaq”, tuttora in espansione e regolarmente fallimentare). Allen è l’eccezione, il suo accostamento è uno dei pochi veramente azzeccati: Reggie “Killer” Miller, altro tiratore mortifero, peraltro di eguale provenienza californiana, e fin da subito si inaugura un binomio destinato a attraversare l’intera carriera del giovane uscito da UConn. Tre buoni anni con gli Huskies di Jim Calhoun, ora si va nel Minnesota che l’ha scelto, anzi no, subito virata direzione Wisconsin, con Marbury a fare il percorso inverso. I Bucks sono una squadra discreta ma non certo ottima per l’Eastern ancora competitiva prima del ritiro di Sua Maestà, e neanche con l’apporto del fu Shuttlesworth, che si ambienta piuttosto velocemente anche al piano di sopra (già da sophomore chiude a 23 a sera), si scollinano le fatidiche 41 vittorie stagionali.
Servono meno partite, a 41 non ci arriviamo: il lockout capita a fagiolo, e i playoff finalmente arrivano. Incide, giusto un pelo, l’arrivo in panchina di George Karl, finalista coi Sonics solo tre stagioni prima, e l’aggiunta in corsa del giramondo Sam “I Am” Cassell, che con Ray e l’altra stella Glenn “Big Dog” Robinson (detentore peraltro delle caratteristiche perfette per svolgere il ruolo di ala “duttile” tanto cara a Karl) formeranno un’altra versione degli inflazionatissimi Big Three. Avversari al primo turno, manco a dirlo, i Pacers di Miller, che regolano senza difficoltà il neonato trio senza concedere nemmeno la gioia di una vittoria. Si farà più combattuta al loro secondo incrocio l’anno successivo, sempre Reggie contro Ray all’ultima bomba con l’altro a un centimetro, ma vince ancora il vecchio Killer di Riverside in cinque gare, in quello che sembrava potesse essere il suo anno prima che il Diesel ne cancellasse i sogni di gloria con 38+15 (!!!) a sera in Finale.
Il 2001 sembra poter dare maggiore gloria: i Big Three sono oliati e girano bene, la franchigia è ai vertici della Estern e come ogni squadra di Karl che si rispetti attacca divinamente, con Ray primo terminale offensivo, che sembra definitivamente “avere il gioco” anche a livello NBA dopo aver assaggiato la vittoria in estate a Sidney. Riescono anche a non incontrare i Pacers, fuori già al primo turno con Phila; eliminano i Magic e poi il Barone e i suoi Hornets (Charlotte, ovviamente), ma sono proprio i Sixers di Iverson e Deke a fermare la loro corsa in finale di conference. Sette gare e una serie combattuta e molto fisica, ma è lo Shuttlesworth mancato a spuntarla, facendo pentole e coperchi e rialzandosi dopo ogni terrificante legnata che Scott Williams gli rifila, con il volto impassibile di chi continuerà comunque a martellare il canestro. He got game, not him, non Ray, che va ancora a casa. Un altro anno costellato di infortuni, playoff solo sfiorati, e puff, l’esperimento Big Three si scioglie come neve al sole: via Big Dog in off season, via Cassell l’off season seguente, in mezzo via anche Ray Allen per far spazio all’emergente Michael Redd. L’NBA è la lega più effimera del mondo, e lo dimostra una volta di più.
Dopo appena 6 stagioni da pro l’uomo che doveva possedere il gioco sembra destinato a una carriera buona dal punto di vista individuale e statistico ma mediocre per quanto riguarda i successi. Pare il classico ottimo scorer, il miglior giocatore di una squadra che non vincerà nulla contando solo, o almeno principalmente, su di lui. I Sonics, in cui finisce nello scambio che porta Gary Payton e Desmond Mason nel Wisconsin, ne sono l’esempio perfetto: non sono una cattiva squadra, potendo contare anche su un secondo violino di tutto rispetto come Rashard Lewis, quando ancora gli infortuni non gli impedivano di giocare decentemente e si preparava a rubare uno dei più sproporzionati contratti che la Lega ricordi, ma non possono neanche pensare di impensierire le corazzate dell’Ovest di quel periodo, in cui le squadre in Lotteria probabilmente avrebbero vinto la Eastern a mani basse. E infatti a metà aprile regolarmente liberi tutti, eccezion fatta per il 2005, in cui Allen con un moto d’orgoglio trascina i suoi a un’ottima stagione e nei playoff riceve addirittura l’aiuto insperato di “Sexy” James (Jerome, non Lebron, che sarà anche il Prescelto ma può solo invidiare il motivo del soprannome del suo omonimo), con un buon contributo assolutamente slegato dal contratto in scadenza (e subito riccamente rinnovato da Isiah Thomas sulla base di 5 partite giocate bene, ma questa è un’altra storia). Comunque sia, oltre a portare San Antonio alla sesta al secondo turno non si va, neanche con un Sexy del genere.
Miller si è ormai ritirato con l’amarezza di vedere le proprie mani immacolate dall’argenteria, e il suo erede designato sembra doverlo mestamente seguire anche in questo. Ovviamente non può essere soddisfatto, chiede sonoramente la cessione e la ottiene nel 2007: Danny Ainge decide di usare uno dei due pacchetti di giocatori e scelte che ha infiocchettato per portarlo a Boston. L’altro, più sostanzioso, ha invece il recapito del Minnesota, ed è il compenso per quello che spera essere il Bigliettone per un posto in prima fila in Finale. He got game raggiunge la sua nuova squadra e non può non tornargli il sorriso: giocherà con la bandiera biancoverde Paul Pierce e con Kevin Garnett, in un’ennesima versione dei Big Three particolarmente ben assemblata.
Il primo anno dovrebbe essere di assestamento per una squadra del tutto nuova e dotata di tre superstar poco abituate a giocare con qualcuno di pari livello; macchè, 66 doppie vu e subito miglior record della Lega con la siga. E’ proprio Allen però, dai più indicato come probabile top scorer viste le praterie che gli altri due gli avrebbero procurato, a faticare di più individualmente, e nei playoff la musica non cambia: poco ritmo offensivo e Celtics che accusano le prime difficoltà, andando in finale di conference ma con 14 partite sul groppone equamente divise con Hawks e Cavs. Ma si sa, coach Doc Rivers è anche e soprattutto un grandissimo motivatore, e per le mani ha gente che di motivazioni ne ha già un’infinità: con i Pistons Garnett domina e torna ai livelli abituali anche il nostro Allen, Celtics in Finale in sei. A vincere la Western sono invece i Lakers: dopo vent’anni ritorna la sfida finale che aveva infiammato la Lega fino agli anni ‘80, LA-Boston, il derby degli USA.
Al primo anno con i Big Three, e che Big Three, Boston torna subito in Finale dopo quasi vent’anni di purgatorio, con una squadra dall’ossatura non più verdissima a dispetto dei colori sociali, costruita per vincere quanto prima e poi sfaldarsi. I Lakers sono più giovani e con meno punte di talento, ma possono contare su quello che è forse il miglior giocatore al mondo nelle partite dal peso specifico notevole e non solo (di nuovo, non serve che vi dica chi sia). Un bel problema per i Celtics, che possono sì fare affidamento sullo specialista James Posey ma non certo per 48 minuti, e così molto spesso è Allen a marcare Bryant, proprio lui che muro difensivo non lo è proprio mai stato. E invece, ironia della sorte, il Mamba è costretto a percentuali tutt’altro che da MVP della Lega qual’era, con Ray che non rinuncia comunque a dare il suo contributo dove è maggiormente efficace, ovviamente l’altra metà campo. Con queste premesse non è difficile capire come possa essere finita: i Celtics sembrano dei predestinati, vincono agevolmente le prime due in casa e rimontano 24 punti in gara 4 allo Staples, violandolo. Tornati a Boston sul 3-2, scherzano in gara 6 coi due acquisti estivi a suggellare il coronamento del progetto con 52 punti equamente distribuiti e la vittoria del tanto agognato Larry O’Brien, addirittura il diciassettesimo per la franchigia più titolata della Lega, il primo per il ritrovato Allen, che dimostra, contro il miglior pariruolo al mondo, di poter avere questo gioco ai massimi livelli su entrambi i lati del campo.
In un periodo che per molti coincide con il declino dunque He got game è tornato, forte di una squadra finalmente all’altezza, e non vuole certo fermarsi ora. Nei quattro anni successivi, nonostante il tempo che passa e gli anni che si accumulano, contribuisce in maniera determinante a portare questa versione dei Verdi nella storia e nei cuori dei tifosi, non solo del Massachusetts. Il punto più alto è la seconda Finale nel 2010, partendo con la quarta moneta del ranking, in cui Boston deve concedere la rivincita ai Lakers solo dopo una tripla ignorantissima dell’allora Ron Artest in gara 7, roba da tagliare le gambe a chiunque. Ma se ne potrebbero elencare molti altri, anche dal punto di vista individuale, nonostante sia riduttivo parlare di individualità in uno dei gruppi più coesi della storia recente: il buzzer beater in faccia a Noah nei playoff 2009 con i suoi spalle al muro dopo aver perso gara 1 in casa, i 51 (cinque uno, con 9 bombe) in gara 6 nella stessa serie, la difesa enciclopedica su Bryant nelle Finals 2010 sacrificando la prediletta fase offensiva, l’orgoglio di mettere in seria difficoltà gli Heat dei nuovi Big Three che ne vogliono ricalcare il modello, ma con qualche anno in meno, nella finale di conference del 2012, dopo due serie molto complicate, arrendendosi solo a una prova irreale di Lebron in gara 6 con le spalle al muro, il tutto dopo che il ridimensionamento era già iniziato con la cessione di Kendrick Perkins, fondamentale pedina difensiva di una delle difese più ostiche viste in circolazione negli ultimi tempi (Thibodeau da assistente ci mise un zampino e anche qualcosa in più). E poi le regular season lunghe e complesse tra acciacchi e anni sulle spalle, l’intensità che si alza proporzionalmente al cronometro e al caldo primaverile, la difesa che non concede più nulla contro qualsiasi attacco, un’intesa di squadra rara in una Lega in cui i cambi di maglia anche pesanti sono normali, l’esponenziale crescita di Rondo all’ombra dei tre, segreto di Pulcinella del loro elisir di lunga vita. E infine, l’11 febbraio 2011, data strana, palindroma, per chi crede nella cabala: proprio coi Lakers nella riedizione dell’ultima Finale, l’allievo supera il maestro, Ray scrive il nuovo record di triple a bersaglio per un giocatore nella Lega, cancellando quello di Reggie Miller, presente al Garden per congratularsi col suo degno erede.
Quando li ha assemblati, Ainge sapeva di costruire una squadra che doveva vincere subito e che non avrebbe avuto molti anni per farlo viste le carte d’identità dei componenti. Hanno vinto un titolo, ne hanno sfiorato un altro, sono anzianotti e acciaccati ma non ne vogliono sapere di mollare un centimetro. Nell’estate 2012 il GM sa che difficilmente questo gruppo potrà arrivare ancora fino in fondo, e sarebbe semplice iniziare la ricostruzione lasciando andare i free agent Allen e Garnett per la propria strada. Ma non se la sente ancora di smantellare questo gruppo fantastico, così offre loro rinnovi importanti e pluriennali, attestati di stima e gratitudine per quanto fatto per la franchigia. Kevin accetta, Ray nicchia: vuole provare a dare un ultimo assalto al titolo, e per quanto sia legato a questo gruppo e a questa città sa anche lui che con loro non potrà farlo. Alla fine prende una decisione sofferta, appoggiato come sempre dall’onnipresente madre: grazie di tutto Celtics, ora però me ne vado in Florida.
E’ una coltellata, per i tifosi ma soprattutto per i compagni. Garnett nemmeno lo saluterà al loro primo incrocio. Perché è comprensibile, per le ragioni più svariate, voler cambiare aria: meno lo è accettare l’offerta del tuo più acerrimo nemico degli ultimi anni come i Miami Heat. Eppure Ray non ha preso la decisione comoda come potrebbe sembrare: sarebbe più semplice chiudere la carriera da re ai Celtics, invece che rimettersi in gioco a 37 anni, con un ruolo completamente nuovo, il comprimario specialista. E l’adattamento non è mai semplice: gioca una stagione discreta, chiudendo in doppia cifra, ma forse sotto le aspettative visti gli spazi che Lebron inevitabilmente crea e la sua innata capacità di trovarti libero in ogni lato del campo. Nei playoff, attesissimo per la sua esperienza, non alza più di tanto il contributo nei primi due turni, nonostante tolga un altro record a Killer Miller (triple a segno nei playoff, stavolta). E’ nella finale di conference con Indiana che inizia ad alzare il volume della radio, facendosi trovare quando i suoi sono in difficoltà contro la fisicità degli avversari, con triple pesanti che costringono i Pacers a uscire di più invece che intasare l’area, con ciò che ne consegue per il proprio attacco. Gli Heat soffrono, ma volano in Finale con gli Spurs, la seconda consecutiva, la terza per l’uomo che ha il gioco.
Il resto è storia: sono favoritissimi ma l’organizzazione di Popovich mette parecchi granelli negli ingranaggi di questa fuoriserie. In un paio di partite Lebron fatica a trovare il bandolo della matassa, Wade per le prime tre, apertamente battezzato, sparacchia a salve, gli Spurs sono sorretti da una mitragliatrice che risponde al nome di Danny Green, il quale stavolta toglie lui un record a Ray, quello delle triple in una serie finale, stabilito nel 2008. Il nostro incassa e tace, e nel silenzio generale gioca una serie pazzesca, tirando benissimo in una Finale equilibratissima al di la di singole partite finite +30 per l’una o l’altra, e in queste condizioni tutto fa brodo. Poi, nella decisiva gara 6, con Miami sotto 3-2, Bosh dopo il rimbalzo guarda solo lui per riaprire, certo involontariamente ma non a torto, perché solo He got game poteva mettere una tripla del genere.
Lebron è il meritato Mvp delle Finals, ha giocato una serie pazzesca, soprattutto quando la palla pesava. Ma se non fosse stato per quel tiro di Allen, Bill Russell avrebbe premiato col premio che porta il suo nome il pupillo Tim Duncan, o forse addirittura Danny Green, e Pop avrebbe un anello per dito della mano. Quel tiro, di horryana memoria (definizione bruttissima eppure tremendamente reale), ha cambiato una storia forse già scritta. Segna il punto d’arrivo di un percorso lungo 17 anni, in giro per gli Stati Uniti, tra il periodo giovanile a Milwaukee, gli anni complicati a Seattle, l’irripetibile esperienza dei Big Three a Boston, fino all’ultimo titolo a Miami col proprio marchio impresso a fuoco. Solo i grandi possono segnare tiri così con quella naturalezza, solo chi ha qualcosa in più degli altri; in definitiva, solo chi è, e lo è sempre stato, He got game. “It might feel good” direbbero i Public Enemy, che oggi, a distanza di 15 anni, potrebbero tranquillamente aggiungere che “he got game, still got game”; nessuno potrebbe contraddirli.