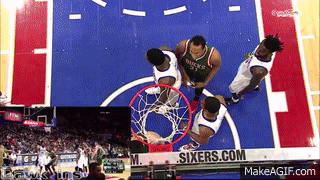Come fa un giocatore valutato da Division III a vincere il Rookie of the Year in NBA? E come fa lo stesso giocatore a passare in tre anni da innovativa point guard, capace di cambiare su chiunque e giocare passaggi di questo tipo, a diventare un problema per chi se lo ritrova a libro paga? Una risposta oggettiva in queste situazioni è difficile da trovare. Forse nemmeno il diretto interessato riesce ad incanalare in un sentiero logico il suo up and down cestistico che lo porta a giocare partite dominanti alternate con prestazioni insipide dalle quali si evince la sua inutilità anche a livello tattico.
Michael Carter-Williams è arrivato in NBA nel 2013, scelto alla 11 dai Philadelphia 76ers orfani di Jrue Holiday sacrificato sull’altare del “processo”. Ci vuole poco per capire che in un ambiente tecnicamente anarchico, dove il livello tecnico assomiglia più alla D-League che alla Eastern Conference, un giocatore diverso dagli altri possa emergere.
Con Noel infortunato, Turner e Young più interessati a capire cosa offrisse il mercato che a giocare per i Sixers e coach Brown ad allenare una squadra costruita esclusivamente per perdere, MCW emerge. In una Lega ancora ignara dell’hype che assocerà alle parole “small ball”, un giocatore di 1,98m con un’apertura alare di due metri capace di esprimere con una certa padronanza doti tecniche da playmaker rappresenta il futuro prossimo del basket statunitense. L’upgrade del ruolo di point guard sembra installato nell’hardware del prodotto di Syracuse, e se le caratteristiche fisiche portano il pubblico al palazzetto, sono le statistiche che mette insieme ad incantarlo per tutti i 42 minuti.
Prima della pausa per l’All Star Game MCW scrive 17,1 punti, 5,4 rimbalzi e 6,4 assist per game incidendo già il suo nome sul trofeo del ROY (complice anche una draft class tra le meno talentuose degli ultimi anni). La squadra non brilla ma la luce di Carter-Williams risplende nel buio di Philly, creando un gruppo di tifosi convinti di aver trovato il prossimo go-to-guy della squadra. Nella stanza dei bottoni però non entrano i tifosi, non entra nemmeno la luce di un ragazzo abituato a dover dimostrare il suo valore davanti a gente più brava.
Alla high school non riusciva a collocarsi tatticamente, finendo per ricoprire tutti i ruoli e consacrandosi nel ruolo di point guard soltanto negli ultimi due anni. Convinto dal blasone di Syracuse è andato a scaldare la panchina nel suo anno da freshman, giocando qualche scampolo di partita senza mai riuscire a convincere coach Boeheim.
L’anno successivo, senza più Dion Waiters e Scoop Jardine, guadagna lo spot di point guard titolare e non lo molla più. Trascina gli Orange alle Final Four dove si arrendono ai Michigan Wolverines di Hardaway jr. e Tray Burke. Quando Sam Hinkie consegna a David Stern la busta con scritto il nome della scelta numero 11 del draft 2013 il percorso intrapreso da un ragazzino del Massachusetts deve sicuramente aver pesato, ma dopo un anno in cui ne sfrutta l’appeal decide di disfarsene. Perché? Gli unici giocatori a finire la stagione d’esordio con statistiche simili a quelle di MCW (16+6+6) furono Oscar Robertson e Magic Johnson. Perché Carter-Williams non poteva diventare il franchise player ossessivamente cercato da Hinkie?
Il 19 febbraio 2015 viene scambiato per una prima scelta. A Milwaukee arriva un giocatore ancora acerbo, abbandonato dalla franchigia che ha solamente abbozzato la fiducia sperata e incapace di trovare una dimensione sui due lati dal campo tale da renderlo effettivamente il playmaker del futuro. E qui entra in gioco il discorso tecnico che se possibile è ancora più insondabile di quello puramente narrativo.
In un articolo di qualche tempo fa Alberto Biasio pubblicato su NbaReligion, evidenziava la pochezza sia qualitativa che numerica delle conclusioni prese da Carter-Williams. La situazione non è che sia migliorata granché, anzi. Dopo la pausa per l’All-Star Game le conclusioni prese da oltre l’arco sono state appena due a partite (una in meno rispetto alla sua stagione da rookie) convertite con un misero 20%.
Il 37,5% delle sue conclusioni avvenivano dopo aver tenuto la palla in mano più di 6 secondi, soltanto il 21,4% dei suoi tiri provenivano da un catch and shot (convertiti con un onesto 33,3%). Quando giocava a Syracuse il suo gioco perimetrale era obbligato dalla mancanza di specialisti nel roster degli Orange. Durante le sue prime due stagioni in NBA si parlava di un giocatore con i classici problemi di meccanica, risolvibili con applicazioni in palestra. Scarsa fluidità nel movimento, spalle che non formano un angolo di 90 gradi, posizione dei piedi non rivolta verso il canestro. In verità questi problemi si sono rivelati strutturali e difficili da risolvere, anche perché arrivare nella lega a 21 anni è diverso dal farlo a 19; le abitudini tendono a diventare meno inclini ad un cambiamento e i ritmi frenetici del calendario non aiutano.
In molti pensavano che il vero problema di MCW una volta salito al piano di sopra fosse abbandonare i concetti della zona di coach Boeheim per assimilare una difesa 1vs1, dove i mezzi fisici possono aiutare soltanto se assecondati da un’attitudine e da un posizionamento del corpo e dei piedi degni della categoria. A dire la verità l’impatto di Carter-Williams quando la palla ce l’hanno gli altri non è nemmeno così catastrofico. Nell’ultima stagione ai Bucks con lui in campo la squadra subiva 1,7 punti in meno per ogni 100 possessi, i suoi numeri dicono anche 1,7 rubate (solo Middleton in squadra ha fatto meglio) e 0,8 stoppate a partita.
Dati comunque in linea con la sua prima stagione e quindi materiale su cui lavorare.
Anche le doti di playmaking sono avvolte in un fitto interrogativo difficile da soddisfare. Che il ragazzo abbia un rapporto speciale con l’arancia è chiaro, meno limpido è il reale utilizzo che la squadra ne fa mentre lui è sul parquet. Lo scorso anno MCW ha utilizzato il 21% dei possessi offensivi dei Bucks mentre era in campo; il 32,5% di Harden è probabilmente esagerato, ma il 26,5% di Kemba Walker ad esempio ci dà l’idea di quanto poco il nostro fosse coinvolto nell’azione.
Estremizzando il concetto, con Carter-Williams in campo i Bucks tiravano il 12,3% delle triple complessive durante la partita, con Kemba Walker gli Hornets tiravano il 26,7% delle loro triple. Questi dati ci spingono verso due conclusioni abbastanza evidenti: Michael Carter-Williams non è un tiratore affidabile e di conseguenza le spaziature della squadra ne risentono. Inoltre è anche un giocatore poco propenso alla creazione di gioco perimetrale, fattore che lo rende molto meno pericoloso, dal momento che il difensore non si deve preoccupare di leggere eventuali linee di passaggio esterne (così come il difensore di un ipotetico ricevitore di quel passaggio) ma deve limitarsi a non concedergli il centro dell’area o comunque il passaggio sul taglio di un compagno. Pena due comodi.
Al suo quarto anno di NBA la classificazione di MCW rimane materia per stregoni e chiromanti. È ancora troppo giovane per essere una meteora, e non è troppo vecchio per essere un futuro All-Star. Tuttavia la trade che lo ha portato ai Bulls spinge inequivocabilmente verso la chiusura di un ciclo di carriera nel quale il giocatore assume i connotati che ne contraddistingueranno le successive fasi.
Carter-William non è un leader, a Milwaukee hanno provato a cucirgli addosso il ruolo di baluardo della second unit, con scarsi risultati. Il suo tiro non ha mostrato segnali di miglioramento, nonostante nello staff di coach Kidd fino allo scorso giugno ci fosse uno dei migliori “shot doctor” della lega, tale Josh Oppenheimer. Il Front Office dei Bucks ha cercato acquirenti per il prodotto di Syracuse fino alla nausea, la stessa provata dal sottoscritto quando è stato annunciato lo scambio con la franchigia dell’Illinois per arrivare a Tony Snell.
Anche il termine delusione potrebbe essere inappropriato perché le aspettative formatesi nel primo anno forse erano il frutto di un processo selettivo volto a cercare il bello in una franchigia modellata per perdere, perdere e ancora perdere. Magari ci siamo sbagliati; MCW vale veramente quanto Tony Snell, forse anche meno dal momento che coach Hoiberg in queste prime uscite ne ha centellinato l’utilizzo (prima dell’infortunio contro i Nets), preferendo affidarsi ad un ragazzo dal potenziale minore ma già definito come Canaan rispetto che a dei punti interrogativi come Carter-Williams e il rookie Denzel Valentine.
Per ora Chicago sta vincendo e convincendo, inserire una variante impazzita come l’ex Sixers rischia di generare più danni che dividendi. Il problema è che questa ultima frase sta diventando sempre di più il leitmotiv della carriera di un giocatore che ha smentito tanti suoi detrattori, prima di smentire altrettanti suoi fan. Adesso bisogna convincere qualcuno. L’NBA è piena di storie di underdog capaci di ribaltare le aspettative altrui, ma è anche ricolma di giocatori incapaci di rispettare l’hype che li accompagnava nella lega. La sabbia nella clessidra di MCW è ancora parecchia, sta a lui adesso decidere come sfruttarla.