Chicago Bulls
Partiamo da quelli che sono “gli sconfitti” dello scambio. Cedere la propria stella nel prime della propria carriera, a maggior ragione se con un contratto così lungo e così conveniente, è una scelta che viene effettuata di rado dalle franchigie NBA, generalmente con l’obiettivo più o meno dichiarato di cominciare a ricostruire praticamente da zero. Se la franchigia NBA in questione, poi, si chiama Chicago Bulls ed è situata al centro di uno dei mercati più floridi della Lega, la trade assume contorni ancor più peculiari. Jimmy Butler è, dunque, l’agnello sacrificale sull’altare del completo rebuilding ideato dal General Manager Gar Forman. La scelta di fare a meno di Butler è stata, per così dire, obbligata: era il pezzo di maggior valore nello scacchiere dei Bulls, l’unico giocatore in rosa che avrebbe potuto ambire un designated player contract tra due anni, nonché l’unico a poter attrarre franchigie disposte a cedere eventuali asset. Chicago sembra caduta in un vortice interminabile di contraddizioni: esattamente dodici mesi fa, nelle ore precedenti al Draft 2016, i Bulls avevano rifiutato un’offerta molto simile da parte dei T’Wolves proprio per Jimmy Butler, decisi a mantenere la propria stella.
Chicago, ad ogni modo, sembrava aver già intrapreso la strada del rebuilding, salvo poi smentirsi clamorosamente. Nella scorsa estate i tifosi Bulls hanno dovuto assister prima alla mancata rifirma di Joakim Noah e poi alla non fortunatissima trade che ha portato Derrick Rose lontano da Chicago: elementi che hanno fatto pensare ad un immediato ridimensionamento della franchigia dell’Illinois, improntato sulla ricostruzione di una squadra composta da elementi più facilmente compatibili con la filosofia di gioco di coach Fred Hoiberg. Poi, improvvisamente, la dirigenza Bulls ha deciso di virare su una nuova linea: in poche ore sono giunti nella Windy City due nomi di grido, ma non certo freschissimi, come Rajon Rondo ed il figliol prodigo Dwyane Wade con due biennali che pesavano complessivamente per oltre 74 milioni in due anni sul Salary Cap dei Bulls. Ma quale ricostruzione? I Bulls si candidavano apertamente per un posto ai playoff, contando però su un nucleo anziano e ben poco conforme all’idea di gioco versatile e fondata sul pace-and-space che coach Hoiberg ha sempre avuto in mente per Chicago (senza mai poterla applicare).
Una stagione dopo i Bulls si son ritrovati eliminati al primo turno, dopo un ottavo posto riacciuffato per miracolo, con evidenti problemi di comunicazione all’interno dello spogliatoio ed un gruppo dalle caratteristiche antitetiche a quelle cercate dal proprio coach. Inoltre, a metà stagione i Bulls avevano scambiato un veterano, Taj Gibson, e quello che era forse il giocatore più vicino alla filosofia di Hoiberg, nonché il miglior tiratore della squadra, Doug McDermott, per un pacchetto-horror composto da Cameron Payne, Anthony Morrow e Joffrey Lauvergne. Che fosse il momento di ripartire, era evidente.
Ma a che pro farlo con un anno di ritardo? E soprattutto: cosa ha reso, 12 mesi dopo, una quasi identica offerta dei T’Wolves irrinunciabile agli occhi dei chicagoani? Domande alle quali non avremo mai risposta. Partendo da queste basi, appare fondamentale identificare le necessità alle quali Chicago ha cercato di trovare risposta con questo scambio: ringiovanire sensibilmente il roster, e dare, finalmente, ad Hoiberg giocatori spendibili per la propria filosofia.
Nell’Hoiberg-pensiero hanno senza dubbio ruoli predominanti la possibilità di giocare con un quintetto composto da giocatori interscambiabili, la volontà di tenere un ritmo alto e il vasto uso del tiro da tre punti. LaVine, Dunn e Markkanen, pur ammantati da una fitta coltre di dubbi, sono giocatori che provano a rispondere, a vario titolo, a queste esigenze. Senza alcun dubbio l’asset di maggior valore ricevuto da Chicago risponde al nome di Zach LaVine, guardia al terzo anno da UCLA e già due volte vincitore della gara delle schiacciate. Essere un classe ’95 con già tre anni di NBA alle spalle fa di LaVine una merce di scambio molto pregiata: abbina all’età da rookie un’esperienza non indifferente nella lega. I dubbi su di lui riguardano prevalentemente due aspetti: la metà campo difensiva e il gravissimo infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che potrebbe minare l’efficacia di un giocatore che fonda in così larga parte il proprio gioco sull’esplosività.

Avete detto “esplosività”?
Se, per un momento, volessimo mettere da parte i dubbi relativi alla sua condizione al rientro e guardassimo alle sue statistiche, avremmo abbastanza chiaro che i Bulls hanno individuato nel giovane Zach il perno per la propria ricostruzione. LaVine è in costante crescita, non solo statistica. E’ un giocatore di grande personalità, che sembra avere le caratteristiche perfette per diventare la stella dei Bulls del futuro. Partiamo dal ruolo: per oltre due anni in Minnesota si sono interrogati sulla posizione da far ricoprire a LaVine, non riuscendo a capire se fossero dinnanzi ad un playmaker o ad una guardia. Questo dilemma viene automaticamente spazzato via con il suo arrivo alla corte di Hoiberg, un forte sostenitore del positionless basketball. In questo contesto sarà, probabilmente ancor più facile vederlo involarsi in campo aperto per far detonare la dinamite che, prima dell’infortunio, ha mostrato avere nelle gambe.

Le maglie allargate delle difese del Rookie Game ci concedono un saporito assaggio di ciò che può essere LaVine con il campo continuamente aperto.
Senza alcun dubbio, poi, lo vedremo prendersi ancora maggiori responsabilità al tiro. I suoi miglioramenti in questo fondamentale sono stati sensibili, tanto a livello di percentuali, quanto a livello di volume di tiri presi: nell’ultima stagione ha viaggiato con il 38.7 % su 2.6 tentativi dal campo.
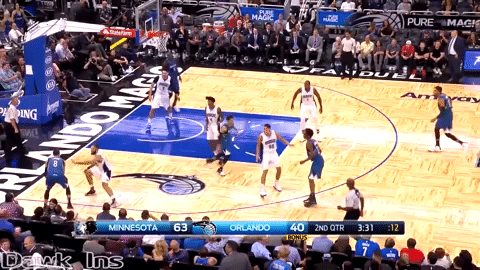
Anche fuori ritmo e da nove metri.
Nelle ultime due stagioni, LaVine ha anche tirato sopra il 50% da due punti, raggiungendo nell’ultima stagione il 54.4% di percentuale effettiva ed il 57.6% nella true shooting percentage, frutto anche di un ottimo 83.6% ai liberi. Quasi una manna dal cielo in un back-court strozzato da guardie senza tiro perimetrale come Rondo e Wade. Certamente LaVine non è un tiratore naturale, ma la sua rispettabilità oltre l’arco lo rende un giocatore su cui diventa difficile difendere alla luce della sua terrificante esplosività quando decide di penetrare.
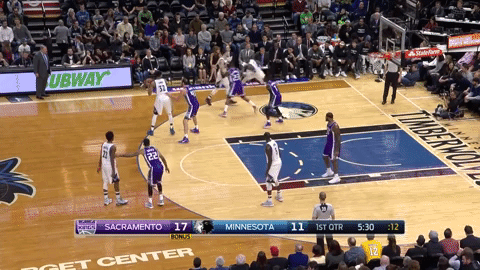
Buonissima fluidità nel palleggio-arresto-tiro da tre, direttamente dopo un hand-off di Towns: la difesa è costretta a rispettare la sua finta di penetrazione, lasciandogli prendere un tiro non eccessivamente contestato.
La sue capacità da realizzatore sono, chiaramente, quelle che verranno maggiormente testate nel prossimo anno. I quasi 19 punti di media realizzati la scorsa stagione sono, probabilmente, destinati a salire. Sarà lui a raccogliere direttamente l’eredità realizzativa di Butler, anche disponendo di armi molto diverse da quelle dell’ex numero 21 dei Bulls. A livello difensivo, invece, il discorso non comincia nemmeno: è evidente che LaVine sia lontano anni luce da Butler per effort e capacità naturale di difendere; il terribile 115 di defensive rating registrato nell’ultima stagione lo dimostra. Anche negli altri comparti del proprio gioco, LaVine sarà chiamato far passi avanti negli anni a venire: dovrà migliorare sensibilmente a rimbalzo e nella lettura del gioco, elementi ancora molto involuti in relazione al talento offensivo e ad all’espolosività mostratici fin ora.

Anche troppa esplosività.
Capitolo Kris Dunn. La point guard al secondo anno nella lega, viene da una rookie season molto difficile: le statistiche grezze parlano di 3.8 punti, 2.4 assist, 2.1 rimbalzi e 1.1 palle perse in soli 17.1 minuti di impiego. Più che i freddi numeri, ad impressionare in negativo è stata la sua incapacità di insediare il posto di titolare di Ricky Rubio in cabina di regia per i lupi e, soprattutto, il suo essere anni luce distante dall’etichetta di NBA-Ready che numerosi scout gli avevano affibbiato.
Dunn è ancora un “progetto di giocatore”: la stazza e le skills per stare nella lega ci sarebbero, ma ha bisogno di dare sostanza ad alcuni fondamentali del proprio gioco. Una su tutti: il tiro. No, non solo tiro da tre punti, proprio il fondamentale del tiro. Complice una meccanica di rilascio lenta e non ortodossa, non adatta ai canoni dell’attuale NBA, Dunn ha vissuto una stagione NBA orrenda per percentuali: 37.7% dal campo, risultato del 40.4 % nel tiro da due e del 28.8 % nel tiro da tre punti, per un complessivo 41.1 % di percentuale effettiva. Pur buttando nel calderone la percentuale al tiro libero (uno scarno 61%), la true shooting percentage si arrampica a mala pena fino al 43.2 %.

Come vedete, Dunn è battezzatissimo: la meccanica è rivedibile, soprattutto nella parte alta, e ogni palla buttata per aria corrisponde ad una preghiera agli dei del basket.
Ad aumentare i dubbi sul giocatore giungono poi le sue migliorabili qualità di lettore del gioco: la sua assist percentage è del 19.4%, addirittura più bassa di quella delle palle perse (20.8%). Certo, questi dati potrebbero essere falsati dalla sua scarsa centralità nel gioco dei T’Wolves dello scorso anno (lo usage si attesta su un 14.2% davvero povero per una point guard). Presi in considerazione questi numeri, come può Kris Dunn essere un fit credibile per Hoiberg? A suo favore giocano quattro fattori: l’età, la stazza, i lampi difensivi mostrati e la sua capacità di alzare il ritmo. Dunn può essere un ottimo rimbalzista a livello NBA per il ruolo (già lo scorso anno ha fatto registrare 4.5 rimbalzi sui 36 minuti) , cosa che gli permetterebbe di correre il campo direttamente da rimbalzo difensivo.

Evitando di far schierare la difesa, Dunn può essere decisamente più pericoloso.
Un altro anno all’ombra di una pass-first point guard come Rondo, potrebbe permettergli di portare energia dalla panchina e lavorare con maggiore calma sui punti deboli del suo gioco in un sistema probabilmente più adatto, in ottica futura, alle sue caratteristiche. La Chicago “ammirata” lo scorso anno era ventesima per pace (ventiduesimi i T’Wolves), ma se la ringiovanita franchigia dell’Illinois venisse plasmata da Hoiberg secondo il proprio pensiero, Dunn – magari migliorato al tiro ― avrebbe pieno diritto di cittadinanza nei Bulls del futuro.
A chiudere il quadro dei nuovi arrivi a Chicago c’è la settima scelta assoluta dell’ultimo Draft: Lauri Markkanen. Il lungo finlandese (213 cm), come affermato nel suo profilo di presentazione pre-Draft, dispone di un tiro da tre estremamente affidabile (42% nell’anno ad Arizona) e rientra perfettamente nell’identikit del 4 moderno. Può essere davvero un ingranaggio importante nell’idea di gioco di Hoiberg, che potrebbe addirittura utilizzarlo da Stretch/Playmaking 5 in un quintetto che apra a dismisura il campo. Era, assieme a Malik Monk, il miglior tiratore del Draft, e i Bulls hanno deciso di puntare su di lui. I dubbi su Markkanen sono inerenti la metà campo difensiva, la capacità di leggere il gioco sotto pressione, la mancanza di atletismo e rapidità di piedi e la sua tenuta psicologica, tutta da testare. Alla luce dei punti deboli del finlandese e di Robin Lopez, era così necessario vendere agli Warriors la scelta numero 38, tramutatasi in un potenzialmente utilissimo Jordan Bell? Gli interrogativi sulle scelte dei Bulls nella notte del Draft si infittiscono.
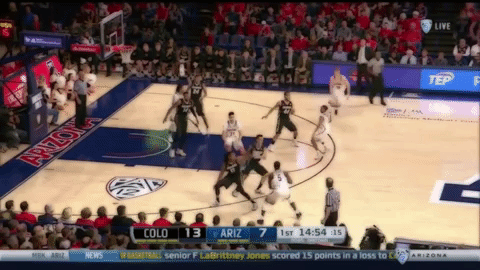
No,decisamente nessun dubbio, invece, sul tiro di Markkanen.
Malgrado la scoperta di tali presunti elementi logici nella trade e certe dichiarazioni di Danny Ainge, l’impressione che Chicago abbia forzato la cessione della sua stella ― ottenendo troppo poco in cambio ― rimane forte, ma i giocatori presi fanno pensare quantomeno alla decisa di volontà di dare ad Hoiberg diverse stagioni per ricostruire su un nucleo giovane e che finalmente si confaccia alla sua filosofia. Scaduti i contratti di Wade e Rondo (che dovrebbero tornare a Chicago per la prossima stagione), i Bulls vivranno con ogni probabilità qualche stagione di tanking prima di provare a tornare nell’èlite della lega. Bisognerà dare a Hoiberg il tempo di poter lavorare e far crescere questo gruppo, anche se il contratto in scadenza al termine di questa stagione potrebbe essere un campanello d’allarme.







