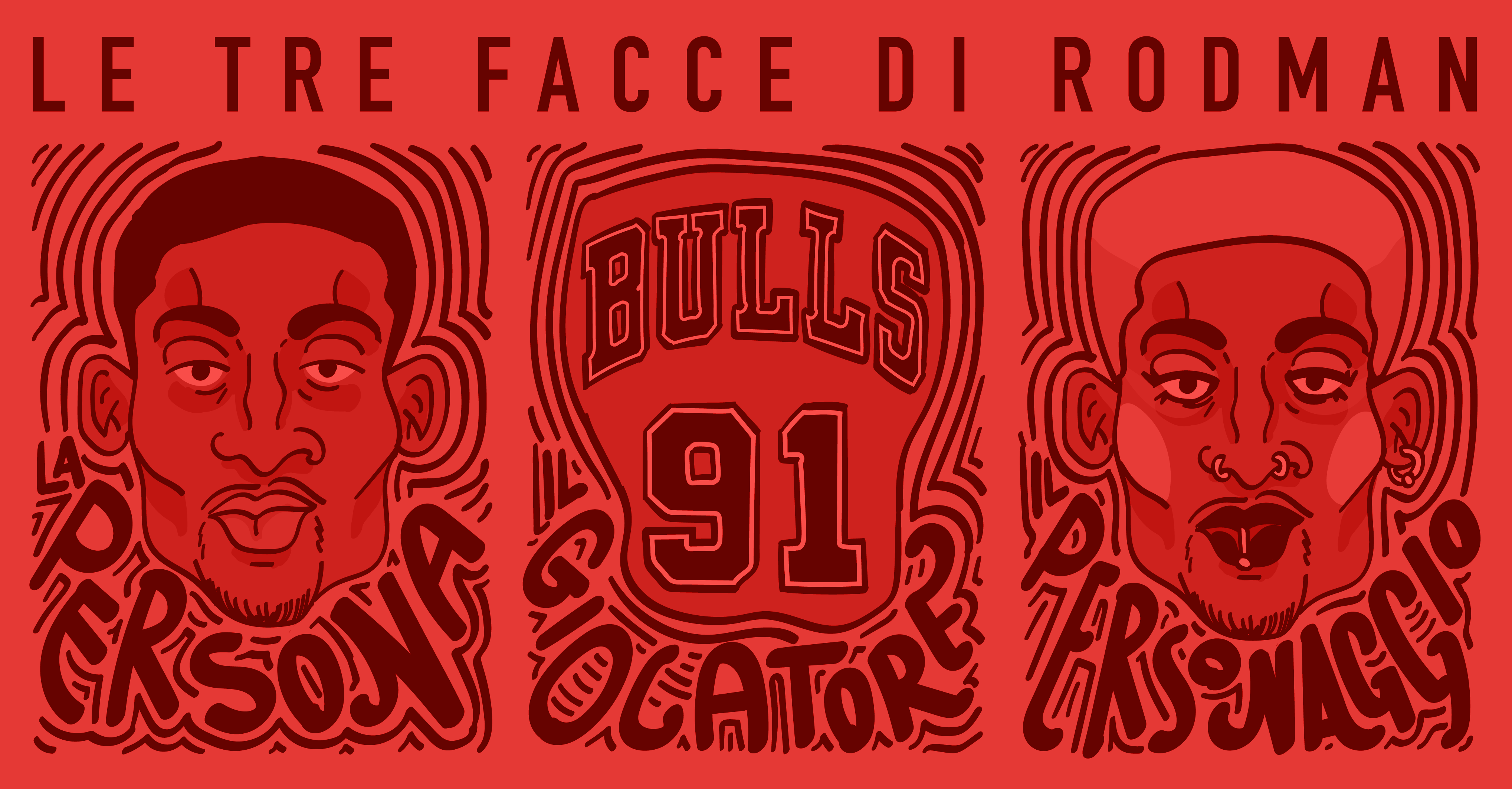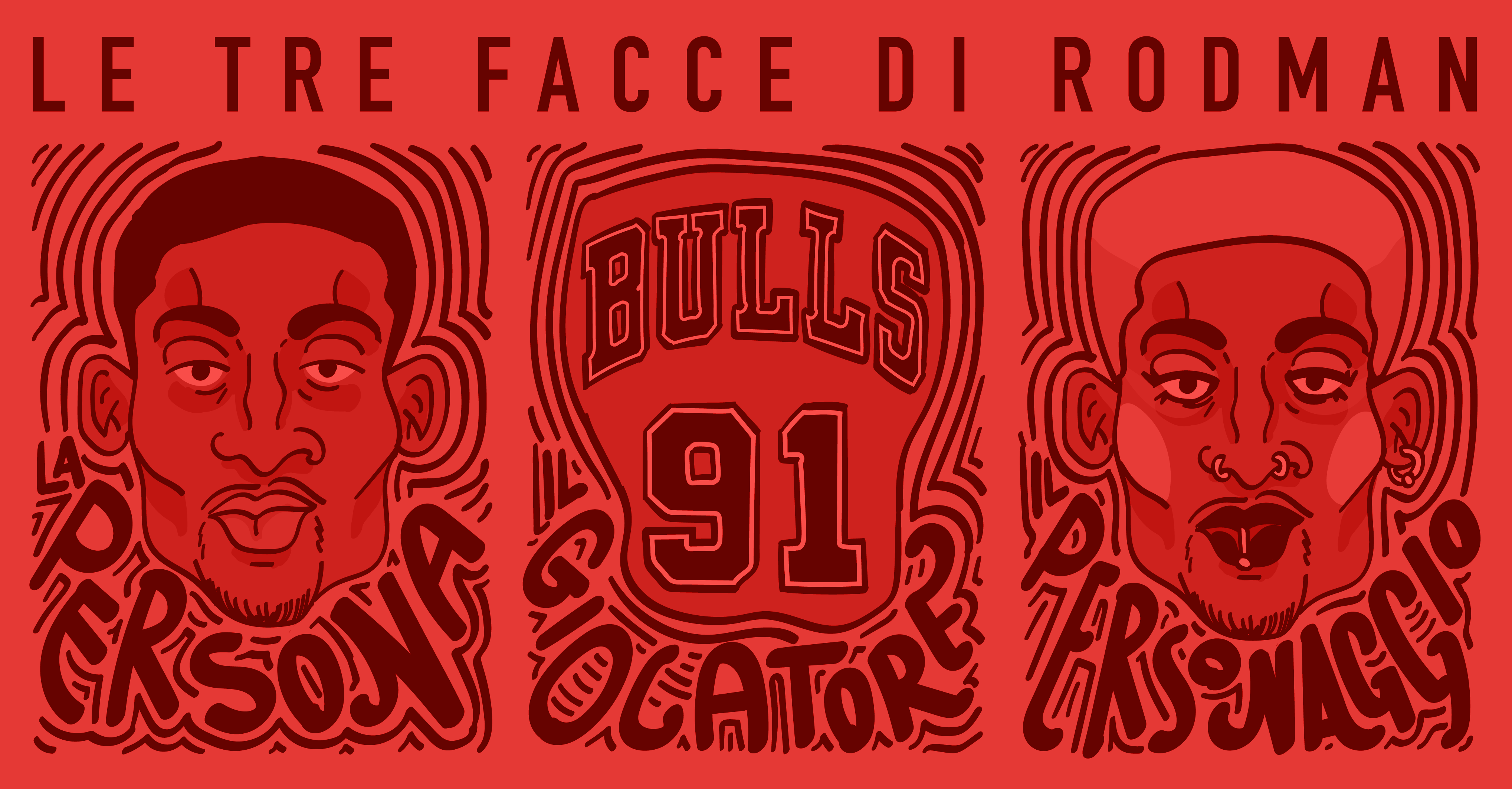Capita spesso di sentire una strana voce dentro la nostra testa. Un rimbombo continuo. Prima di un derby, prima del classico uno contro uno al campetto con quel ragazzo che ti batte da quando hai sei anni, nelle infinite “due file” prepartita durante le quali butti l’occhio verso quell’ex allenatore, ora avversario, che, non molto prima, ti ha fatto ammuffire un’intera annata in panchina. Lo senti dentro quello strano brivido, sale, sale sempre più. Poi la palla a spicchi ti scorre tra le mani, è sempre lei, tutto il resto scompare. Quella vocina però resta, sommessa, quasi di sottofondo. Ti ricorda che con quella palla devi creare qualcosa d’inarrivabile, per quaranta minuti il campo dev’essere solo tuo, perché quella che stai giocando è più di una partita.
I vincenti, secondo l’ideale comune, assecondano questo pensiero continuo, lo cullano, lo rendono parte del loro respiro e, quasi inevitabilmente, alla sirena finale se ne vanno con le braccia alzate. I perdenti invece salutano il campo a testa china, con la maglia portata agli occhi, coprono quella tensione trasformata in copiose lacrime.
Oggi però voglio ridefinire il concetto di vincente.
Per farlo mi reco nel profondo sud statunitense. Mississipi, primi anni ’60. Ross Barnett è stato da poco nominato governatore. È forse il segregazionista più convinto della storia politica americana . Ora, provate a mettervi nei panni di un giovane ragazzo di colore di Jackson, bravo con l’arancia in mano e voglioso di studiare. L’equazione per noi giovani del ventunesimo secolo sembra banale e scontata: gli basterebbe una borsa di studio a Mississipi State, l’università più conosciuta dello Stato. Si, peccato che ci siano tre lettere che, all’epoca, cancellavano direttamente l’equazione stessa, senza nemmeno provare a risolverla, anzi, sputandoci sopra. KKK, Ku Klux Klan, lo possiamo chiamare come vogliamo, il significato resta sempre e solo uno straziante susseguirsi di violenze razziali corporali e, a causa di molti politici, legislative.
Corre l’anno 1963, i Maroons (ora conosciuti come Bulldogs) di coach McCarty si allenano come sempre; una quindicina di ragazzotti con magliettine succinte, a capeggiare la scritta “MSU” sul petto. Piccolo particolare, sono tutti bianchi. Hanno i volti abbattuti nonostante l’ennesimo titolo SEC messo in tasca. Anche quest’anno sanno che non potranno ambire al titolo a causa di quell’incredibile legge che non permette loro di giocare contro ragazzi di colore. Loyola, prossima avversaria, ritenuta terza squadra più forte di quell’annata collegiale, vede difatti tra le sue fila la presenza di quattro afroamericani. Impossibile partire per Chicago.
Ed è qui che nasce la leggenda. Coach McCarty è stufo di vedere i suoi ragazzi non ripagati degli sforzi sul campo e, con l’aiuto del rettore Dean Colvard, quasi fiabescamente, riesce a far evadere la squadra dai confini statali. Alcuni via terra verso Memphis, altri in aereo, Nashville come meta d’incontro. Un viaggio impensabile, avvenuto anni prima della favola di Don Haskins e dei suoi Texas Miners (protagonisti del celebre film “Glory Road”)
Nel momento in cui i Maroons stanno sorvolando i prati verdi del Tennesse, a Chicago, i Ramblers di Loyola continuano a ricevere minacce di morte dai membri del KKK.
Ed ecco ripresentarsi quella stessa vocina, nelle teste dei giovani ragazzi di campagna diretti in una città, in una partita più grande di loro. Quel brivido che continua a salire sulla schiena di coach McCarty, la testa che fa fatica a ragionare. Harkness (giocatore di spicco di Loyola) che apre l’ennesima lettera di minacce firmata con quelle tre lettere. L’ennesima negazione del suo essere uomo, del suo essere giocatore.
Tensione mista a paura. La consapevolezza di scrivere la storia.
La vocina cresce, sempre di più. Il viaggio verso la palestra. Le scarpe strette per non scavigliarsi. L’ingresso in campo. I volti sorpresi dell’una e dell’altra squadra che si scrutano quasi invisibilmente, ma continuamente per tutta l’ora che precede la partita. La vocina si fa sentire sempre più, come il pubblico. Tre minuti, poi due, uno. La sirena.
Entrano i due quintetti in campo, come sempre, come mai prima di quel momento. La palla a due, la stretta di mano tra i due centri. Uno è bianco, l’altro è nero. La vocina non è più interiore, è diventata un urlo. Un grido fortissimo al mondo, che segnerà il futuro del basket e della vita sociale americana.
La palla a spicchi tra le mani, una sensazione strana però, sembra quasi che la vocina sia improvvisamente svanita, come la voglia di giocare quella partita per il risultato. I dieci in campo e gli altri in panchina hanno già conquistato quello per cui hanno combattuto. Sanno tutti che quella è più di una partita e, hanno tutti già capito, d’averla vinta.
A distanza di mezzo secolo accendo la televisione, ci sono i Gators in campo. Il quintetto comprende un ragazzo bianco, tre di colore ed un ispanico. Dall’altra parte, Georgia schiera un quintetto che di certo farebbe arrabbiare tutti quei bigotti incappucciati che non molto tempo fa minacciavano chi ha cambiato il suo Paese ed il nostro amato sport.
Con questa bella storia vorrei cominciare il mio impegno settimanale con il panorama NCAA, dove il basket molte volte, se non sempre, è ben più della semplice palla che scivola nella retina.