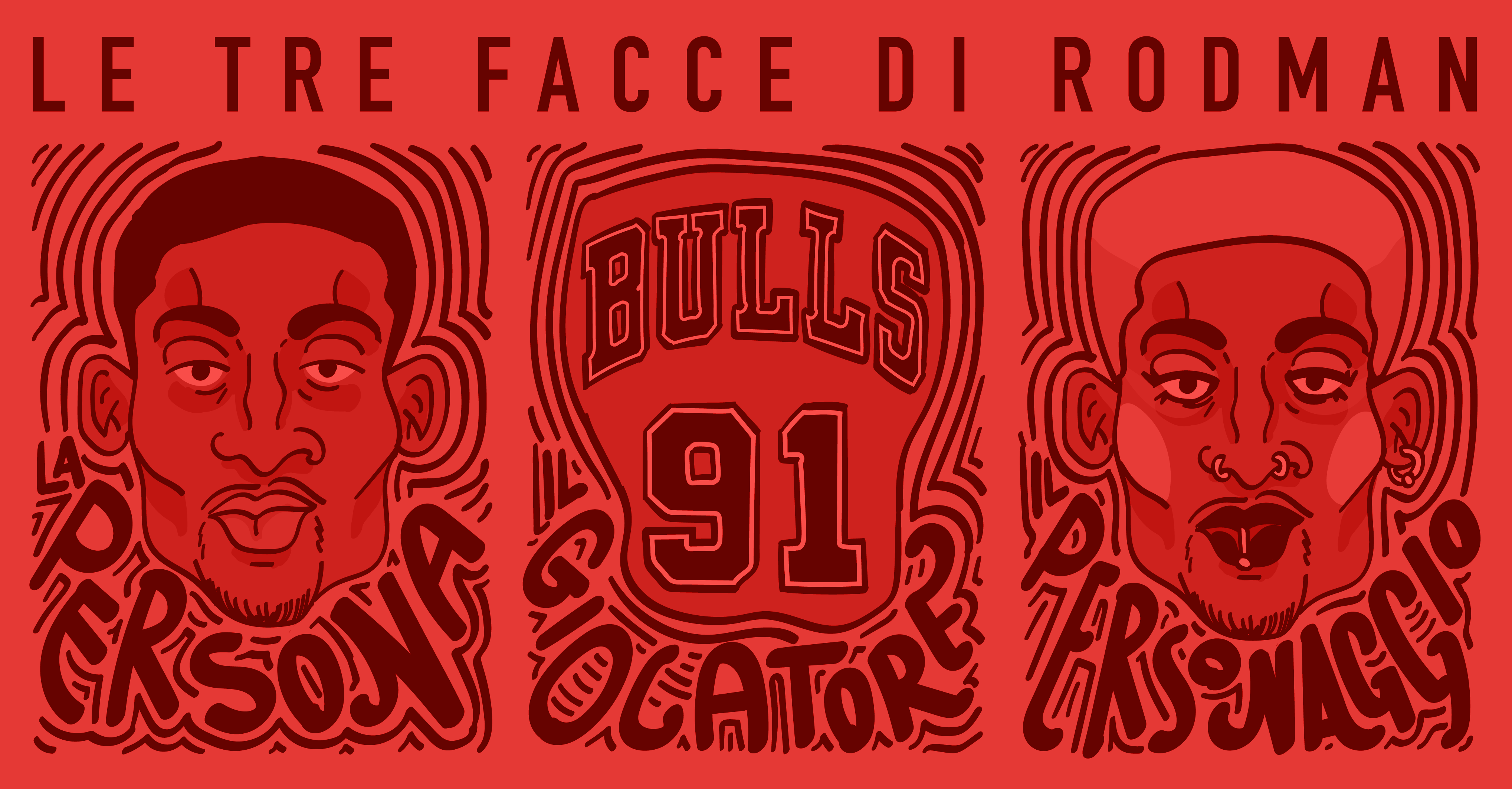«Ehi Darnell! É vero quel che si dice in giro?»
«Cosa?»
«Beh…che se ti mettono un quarto di dollaro sull’angolo più alto del tabellone, salti talmente in alto che riesci a prenderlo.»
«Mettici un centone e sta a guardare!»
Questa è grossomodo – parola più, parola meno – la conversazione che si tenne in un giorno ordinario durante un allenamento degli Indiana Pacers, scaturita dalla curiosità reale e comprensibile di un reporter.
Riguardo al suo oggetto, sorge immediatamente l’istinto di considerarlo uno di quei racconti frequentemente ricorrenti e spesso etichettati come leggende metropolitane, che aleggiano a mezz’aria tra realtà e iperbole, le quali, come tutti possono ben constatare, tendono irrimediabilmente ad essere separate da una linea di demarcazione molto labile, quasi impercettibile e malleabile alla volontà e all’interpretazione dei sensi.
Con queste premesse, se la storia in questione sia verità o semplice mito non è dato sapere, ma non è importante, perché anche la storia più bella, più entusiasmante e coinvolgente richiede un po’ di romanzo, una goccia di fantasia e inventiva; perché ciò che rende un eroe tale non è l’accaduto, bensì come viene riportato. E’ il racconto che fa l’eroe, non viceversa.
Posso scrivere queste e altre cose, ma non posso decidere per voi a cosa credere. Una cosa in più, però, posso raccontarvela, anche perché vi ho lasciati orfani di un finale.
Ascoltata la proposta di Darnell, il reporter, che prima si dava di gomito coi colleghi sghignazzando, ha smesso di sorridere, ha deglutito e dalla tasca ha fatto spuntare, con un gesto lento e insicuro, una testa di Benjamin Franklin. Poi ha guardato il tabellone.
«Cazzo se è in alto! E come ci arriva questo?» ha pensato, mentre, volgendo lo sguardo, incontrava il sorriso bonario e beffardo del suo interlocutore.
Sotto un casco di capelli irsuti Darnell sorrideva e non c’era paura o insicurezza nel suo sguardo. «Beh, allora? Che aspetti?» sembravano dire i suoi grandi occhi marroni. Il reporter l’ha guardato un’ultima volta e poi, con un gesto tanto lento, quanto quello con cui li aveva fatti sporgere dalla tasca, ha risospinto i 100 dollari sul fondo della stessa, tenendoseli ben stretti. Se la scena sia stata esattamente così non lo so, ma ve l’ho detto: è il racconto che fa l’eroe, non viceversa. L’eroe in questione però, come avrete facilmente intuito, non è il reporter, che, beato lui, è rimasto più ricco di 100 dollari – scalando posizioni nella mia personale classifica di idoli –, ma il suo interlocutore: Darnell Hillman. E questo è il suo racconto.
Darnell albeggia a Sacramento, California il 29 Agosto del 1949. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il primo amore di Darnell non è la palla a spicchi, ma il Football. C’è un problema però: il ragazzo cresce quasi senza sosta e l’altezza comincia a diventare un problema per muoversi con l’agilità necessaria sul “gridiron“.
Darnell decide quindi di sposare la pallacanestro. Solo che correre a perdifiato, scattare, far mulinare le gambe, gli piace troppo e gli riesce anche naturale, visto che Madre Natura, che – ahinoi normodotati! – è chirurgo raffinato, da premio Nobel, ma spesso diabolico, ha deciso di dotarlo di un fisico straordinario, in grado di combinare velocità, forza e potenza con la stessa facilità, con cui io, durante una giornata qualunque, infilo la tripletta “pranzo-caffè-sigaretta“.
E allora che fare, se il matrimonio con il Basket non ti soddisfa pienamente? Semplice! Ti trovi un’amante! E Darnell la trova: l’Atletica leggera. Comincia infatti a dedicarsi con una certa insistenza alla corsa e, soprattutto, al salto in alto, facendo intravedere, oltre ad un talento naturale, anche un forte spirito competitivo.
Primavera del 1968. Darnell si sta allenando nel salto in alto sulla pista di atletica della San Josè State University. L’asta è posizionata ad un’altezza di circa 180 cm e Darnell riesce a superarla sempre senza problemi. Tutto sembra procedere tranquillamente, fino a quando due ragazzi, anch’essi studenti dell’ateneo impegnati in una sessione d’allenamento, gli si avvicinano. Lo sguardo è quello tipico dell’afroamericano che aspetta solo un pretesto per metterti a terra e le buone intenzioni sembrano averle lasciate a casa.Uno dei due, John, prende l’asta posizionata a 1 metro e 80 e la scaraventa per terra.
«Se ti vedo ancora saltare l’asta a quest’altezza, ti sbatto a terra e ti trascino per la pista. – dice rivolgendosi a Darnell – Ora metti l’asta a 2 e 10 e non salti più in basso di così tutti i giorni». Detto, fatto. Una settimana dopo Hillman salta i 2 metri durante un meeting. Acqua fresca e record di specialità dell’università, ancora oggi imbattuto.
«Avevo capito il messaggio di John. – dice Hillman – Aim High!/Punta in alto!».
A proposito di puntare in alto: il John in questione altri non era che John Carlos, mentre il suo compare era Tommie Smith e, di lì a qualche mese, si sarebbero ammantati di eterna fama proprio per aver “puntato” ciascuno al cielo il proprio pugno, racchiuso in un guanto di lucida pelle nera, nell’atto di condividere il podio dei 200 metri piani ai giochi olimpici messicani. Un gesto di importanza storica, che avrebbe portato agli occhi del mondo il movimento di ribellione afroamericana delle Black Panthers. Il tutto è immortalato in una fotografia, che è entrata a far parte della storia dello sport e non sembra intenzionata ad uscirne, ma questa è un’altra faccenda.
Solo una grande donna, però, può stare dietro a un uomo e renderlo grande a sua volta. E spesso e volentieri sono le mogli a farlo, non le amanti. Lee Krasner ha reso Pollock grande e permesso che la memoria di lui e della sua opera non svanisse mai, non Peggy Guggenheim. Così è stato anche per Darnell Hillman – non si offenda Pollock sottoterra e speriamo neppure Peggy Guggenheim -. E’ grazie al basket, infatti, che Hillman viene reclutato dalla Hiram W. Johnson High School di Sacramento, dove ha l’occasione anzitutto di diplomarsi e, in seconda battuta, di mettersi in mostra come uno dei talenti più promettenti nel ruolo di Ala Forte in ottica universitaria.
E’ il 1967, siamo alle porte degli anni ’70, e il sistema universitario californiano sta vivendo un momento d’oro, che non si sarebbe più ripetuto. Nello Stato dell’orso rosso stellato i College sono vere e proprie pòleis greche, centri di cultura in grado di originare e indirizzare pensieri e coscienze. Da qui sta partendo una rivoluzione culturale che avrebbe presto investito tutto il mondo, segnando un punto di svolta nella storia dell’umanità. Una rivoluzione che avrebbe cambiato profondamente gli scenari esistenti, aprendo la strada alla contemporaneità. Oltre a tutto ciò, le università californiane possono vantare programmi cestistici del più alto livello, grazie ai quali stanno facendo incetta di vittorie e titoli NCAA. L’Atene degli atenei (scusate il gioco di parole) è senza dubbio UCLA, dove i Bruins, allenati dal leggendario coach John Wooden e rappresentati da atleti-studenti di primo livello – fra cui Kareem Abdul-Jabbar, Sidney Wicks, Lucius Allen, Jamaal Wilkes – sembrano non saper far altro che vincere titoli nazionali in fila; ma anche le varie Santa Clara, Berkeley, UCSF (University of California at San Francisco) e USC (University of Southern California) stanno attraversando stagioni sportive memorabili.
Darnell nutre una duplice speranza riguardo alla propria carriera universitaria: rimanere in California, a un tiro di schioppo da casa, e possibilmente ricevere una chiamata da un’università di primo livello.
La prima magia gli riesce, la seconda no.
A farsi avanti per lui, offrendogli una borsa di studio per il basket, è infatti la piccola San Josè State University – le cui squadre sportive, manco a farlo apposta, portano sulla maglia la scritta “Spartans”, che sia un caso? –, di certo non nota per le vittorie, dato che, in tutta la sua storia, riuscirà a vedere il proprio nome nella lista dei partecipanti al torneo NCAA solo per tre volte. Il soggiorno di Darnell a SJSU durerà però poco. Pochissimo. Praticamente un battito di ciglia. Nella Baia si ferma due anni.
Il primo, secondo quanto previsto dalle regole dell’epoca, lo vede assoluto protagonista con la maglia della Junior Varsity – sostanzialmente la squadra B dell’università, quella destinata agli atleti del primo anno –, con la quale fa registrare medie impressionanti (15 punti e 16 rimbalzi ad allacciata di scarpe), ma soprattutto vittorie, tante vittorie. Contro le squadre della Bay Area, poi, fa mambassa. I piccoli Spartans, guidati da Hillman, le bevono tutte come shots di Vodka. Cal, Stanford, Santa Clara, Saint Mary’s, UCSF, sconfitte tutte. Che Darnell l’avesse presa sul personale? Probabile.
Dopo il “rodaggio” con la squadra dei freshman, Hillman passa in prima squadra, ma la musica non cambia. Con lui in squadra San Josè fa registrare un record di 16 vittorie e 8 sconfitte, producendo ben 82 punti a partita, tutt’ora record dell’università su stagione singola. Tra le 16 vittorie una spicca per prestigio su tutte le altre: quella contro i Broncos della Santa Clara University.
Santa Clara è un college che a molti potrebbe anche dire poco, ma nel ventennio compreso fra la metà degli anni ’50 e la metà dei ’70, in ambito cestistico collegiale, rappresenta una vera e propria istituzione. Tra il ’52 e il ’54 i Broncos, allenati da Bobby Feerick, son clienti fissi del torneo NCAA (Final Four nel ’52 e Elite Eight nei successivi due anni). Nel 1954 un biondo, che gioca Ala per Feerick a Santa Clara, finisce sulla copertina di Sports Illustrated.
«Va beh niente di strano no? Ci è finita anche Tyra Banks, capirai che svolta!» penserete. E invece no.
Quel biondo è Ken Sears e passerà alla storia per essere stato il primo giocatore di pallacanestro – attenzione! Non il primo cestista universitario, proprio il primo cestista in assoluto! –, a cui il noto magazine americano ha deciso di riservare una propria copertina.
Quando, nel 1962, Feerick lascia per andare ad allenare in NBA i Warriors, che si sono appena spostati da Philadelphia a San Francisco, portandosi appresso Wilt Chamberlain, la squadra passa nelle mani di Dick Garibaldi, già protagonista coi Broncos da giocatore, assieme a Ken Sears, della storica cavalcata fino alle Final Four del 1952. Con un cognome così l’attitudine al comando non può mancare e infatti Dick è un condottiero straordinario. Sotto la sua ottenne guida, i Broncos di Santa Clara, il cui colore ufficiale, oltretutto, è il rosso – è evidente come al destino, a volte, piaccia divertirsi! –, compilano un record complessivo di 137 vinte e 77 perse. Il quadriennio fra il 1967 e il 1971, poi, è straordinario. 77 partite accompagnate da una W e solo 10 recanti al loro fianco la lettera L. Una di quelle 10 è proprio quella contro gli Spartans di Darnell Hillman. Una fra le più brucianti, anche perché trattasi di una sconfitta al sapore di Derby.
E sì! Perché per oltre 70 anni Santa Clara non ha avuto un proprio campo su cui disputare le partite casalinghe (fino al 1975 quando è stato costruito il Leavey Center) e indovinate a chi lo chiedeva in prestito? Ovviamente agli Spartans, le cui mura amiche erano quelle del San Josè Civic Auditorium. Un edificio storico, sorto negli anni ’30. Un edificio le cui mura hanno ascoltato discorsi del presidente Nixon, il cui pavimento ha accolto il sudore e il sangue di Joe Louis, i cui soffitti hanno amplificato il suono ruvido della Gibson di Keith Richards e la fumosa voce di Mick Jagger. Se a tutto questo aggiungiamo che la sconfitta ha posto fine alla rincorsa alla “stagione perfetta” dei Broncos, la drammaticità del quadro raggiunge livelli “Caravaggieschi”.
È il 21 Febbraio del 1969. I Broncos hanno vinto 21 partite consecutive, la casella delle sconfitte, invece, è ancora vuota dall’inizio della stagione. Tra qualche settimana comincia la March Madness e, con essa, il torneo NCAA e Santa Clara vuole arrivarci da imbattuta, dato che il numero 2 del ranking nazionale – i proprietari del numero 1 ovviamente son quelli che hanno il campus tra Westwood e Beverly Hills – è già suo. La squadra di Garibaldi è guidata in campo dal Centro Dennis Awtrey e dal duo di Ali composto dai gemelli Ogden. Ralph da ala piccola e, soprattutto, Bud da ala grande. Bud è un giocatore straordinario. Nel suo anno da Junior (1967) nel canestro della Pepperdine fa piovere 55 punti (a tutt’oggi record dell’università) e nei 4 anni coi Broncos totalizza complessivamente 1.437 punti, con una media di 18.2 a partita (3° all-time nella classifica di categoria dell’università). Insomma i Broncos sono una corazzata, ma non hanno fatto i conti con Darnell. E Darnell ha deciso che quella partita si vince. E così è.
Nonostante una performance superlativa di Awtrey, che alla voce punti, a fine gara, scrive 37, i Broncos, complice anche una pessima serata al tiro di Bud Ogden, che, limitato dalla difesa di Hillman e da un problema alla caviglia, sbaglia i 10 tiri presi nel primo tempo e chiude con soli 13 punti, si arrendono agli Spartans, al termine di un doppio overtime, con il punteggio di 73-69. Una delle più belle partite che il College Basket ricordi. A San Josè è tripudio. «Quella fu l’unica volta, nei miei quattro anni a SJSU, in cui battemmo i Broncos» dice Tim Holman guardia e capitano degli Spartans all’epoca. La sconfitta lascerà dei segni profondi nell’anima dei Broncos, i quali, arrivati nuovamente all’Elite Eight del torneo NCAA, verranno sconfitti sonoramente dai Bruins di UCLA, ricevendo una “suonata” di 38 punti. Una debàcle clamorosa.
Dopo la storica vittoria contro gli odiati rivali, Darnell gioca con gli Spartans ancora qualche partita, mettendo complessivamente a segno 15.3 punti di media, pur non essendo il tiro la specialità della casa. Quello che lo contraddistingue e lo rende speciale, infatti, sono le doti atletiche straordinarie di cui è fornito, che gli consentono, assieme ad un’elevazione da fermo di oltre 1 metro, di essere un fattore sotto le plance – alla voce rebounds per game scrive: 14.2. Ripeto: 14.2! – e a protezione del ferro, con delle stoppate perfette per tempismo e disumane per l’altezza da terra alla quale avvengono. E non è tutto. Sì, perché è partendo da qui che comincia ad affinare la tecnica del fondamentale più spettacolare che la pallacanestro consenta ai suoi attori. Quella giocata che fa drizzare i capelli, che fa emozionare il pubblico, che è in grado di cambiare emozionalmente l’inerzia di una partita. Quella giocata che negli highlights entra sempre, spesso e volentieri occupando le prime posizioni. Quella giocata che è il simbolo più puro e, al contempo, grezzo della dominanza e dello strapotere fisico: La Schiacciata.
Darnell Hillman ne era, è e per sempre sarà un esteta. Un uomo capace di trasformare un gesto di forza e coordinazione in un’arte, in uno stile di vita. Sa schiacciare in tutti i modi, Darnell: con forza e vigore pianta una bìmane in testa all’avversario, per poi, nell’azione d’attacco successiva, librarsi leggero in aria e, con una piroetta e un ampio movimento delle braccia, depositare la palla dentro al ferro, mostrando una grazia e una delicatezza più acconce ad una candida ètoile del Bolshoi, piuttosto che ad un ragazzotto afroamericano di 2 metri e rotti.
Tutti ricordano Darnell Hillman per le schiacciate. A dir la verità per le schiacciate e anche un’altra cosa, di cui vi dirò più avanti, ma son sicuro che avrete già intuito guardando le foto. Tutti, meno uno. Chi? Ovviamente Darnell Hillman.
Non provate ad andare a dire a Darnell che tutto quello che sapeva fare era “Dunkin’ the ball”, come dicono oltreoceano. Non è che si offenda, di più. «Chiunque si ricorda di me per le schiacciate, ma pochi sanno che ciò che più amavo fare era stoppare. – dice Hillman – Il mio forte era la difesa. Le schiacciate arrivavano perché il mio ruolo nei Pacers era quello di Sesto Uomo. Entravo dalla panchina al posto di George (McGinnis ndr) o Mel (Daniels ndr) e il mio compito era quello di dare energia alla squadra, alla partita, al pubblico e quindi, quando potevo, I dunk’d the damn rock! Ma ciò che mi dava più soddisfazione, ciò che mi faceva davvero sentire importante per la squadra, era dare tutto nella metà campo difensiva.»
Una sera del ’72, con la maglia dei Pacers, di stoppate ne pianta addirittura 10. Record franchigia. Eguagliato – attenzione! Eguagliato, non battuto! –, oltre 30 anni più tardi, da uno con un cognome pesante per giocare Centro in NBA nei primi anni 2000 e che due o tre cose con la maglia dei Pacers, a memoria, deve averle fatte vedere: Jermaine O’Neal.
Il ricordo che più piacevolmente tocca le corde del cuore di Darnell è, però, un altro. 1971. Prima stagione fra i Pro con la maglia dei Pacers. Regular Season ABA. Indiana è in trasferta in Virginia per giocare un back-to-back contro gli Squires. La neonata franchigia dello Stato che deve il suo nome alla Regina Elisabetta I ha appena fatto firmare un contratto a un’Ala Piccola dell’Università del Massachussetts. È un ragazzo alto, slanciato, con un Afro così sulla testa ed è pronto a prendersi la lega della palla rossa bianca e blu, anche se nessuno ancora lo sa. Il suo nome è Julius. Il cognome non ve lo dico, perché di Julius ne esiste uno solo, come la Coca-Cola.
La prima sera Julius non fa prigionieri. Maltratta Hillman e il canestro dei Pacers. Ne segna 44, con lo stesso sforzo che serve a un comune essere umano per alzarsi dal letto la mattina. La sera dopo, però, la musica subisce una variazione di melodia. Hillman si sente Ludovico Van e suona tutte le note che il suo pianoforte difensivo conosce. Julius prova a ribellarsi e a non farsi intimidire e prende lo stesso numero di tiri della sera precedente. Solo che, questa volta, il risultato finale è leggermente differente: di punti, a referto, ne iscrive 13. Tredici proprio come quelli che Darnell concesse a Bud Ogden nel Febbraio del ’69.
«Quella è la partita di cui sono più fiero. – confessa Darnell – Quella sera, al Dottore, la ricetta l’ho fatta io.»
A proposito di Bud Ogden e del Febbraio ’69, il racconto dell’eroe Darnell si è fermato a quella data. Mi tocca proseguire, non posso mica lasciarvi col fiato in sospeso.
Mentre i Broncos approdano al torneo NCAA venendo battuti da UCLA alle Elite Eight e Ogden affoga la delusione con una comparsata, pure lui, sulla copertina di Sports Illustrated, la stagione degli Spartans si chiude senza l’accesso al più prestigioso torneo del College Basketball. Tuttavia la partita del Febbraio del 1969 era stata trasmessa via radio dalla stazione delle Forze Armate degli Stati Uniti e qualcuno ai piani alti si era accorto di Darnell Hillman. «Però, forte sto numero 45! Vedete di andare a convicerlo a giocare per noi.» E così avviene.
Una delegazione dell’esercito si presenta al campus di SJSU e, con il più classico dei “We Want You!”, convince Darnell a mollare il college e unirsi alla squadra All-Stars delle forze armate. D’altronde è il 1969. Son gli anni del Vietnam, l’esercito gode di un certo potere e sa essere molto persuasivo.
Darnell, che è pure un bravo cittadino e un vero americano, non ci pensa due volte. Accetta. Fa fagotto. Saluta l’allegra compagnia del college e si unisce allo U.S. Armed Forces All-Star Team della AAU (la lega sportiva amatoriale americana), del quale rappresenta la ciliegina sulla torta.
La squadra, composta da elementi come Fran Dunphy (attualmente coach di Temple University) e Garfield Smith (che avrebbe poi giocato per i Boston Celtics nella NBA), è fortissima, un vero e proprio carrarmato. Tra il ‘69-‘70 e il ‘70-‘71, gli All-Stars giocano più di 300 partite, perdendone appena 2! 2 su 300! Numeri da Harlem Globe Trotters. Chiaramente, sia nel ‘70, che nel ‘71 vincono il campionato AAU col tappeto rosso, con Hillman che continua a dare spettacolo. Nel ’70, addirittura, stabilisce il proprio carreer high di 47 punti e viene nominato MVP del torneo AAU.
Tra gli assistenti di quella squadra, c’è un piccolo ragazzo coi capelli nero corvino, di origini polacche, che ha appena ultimato il percorso di formazione a West Point, sotto la guida del leggendario Bobby Knight (storica guida degli Army Black Knights, ma soprattutto indimenticato, maleducatissimo e politicamente scorretto coach di Indiana University). È Knight ad averlo mandato lì a farsi le ossa e a imparare il mestiere di assistant coach. E lo imparerà, cazzo se lo imparerà!
Quel piccolo figlio di immigrati polacchi altri non è che Mike Krzyzewski, altrimenti noto come Coach K, ovvero l’allenatore più vincente della storia del College Basketball (superando proprio Knight in questa speciale classifica), ancora in attività sulla panchina dei Duke Blue Devils e detentore di ben 4 ori olimpici con Team USA (due da assistente 1984-1992 e due da capo allenatore 2008-2012). Il giovane Coach K rimane estasiato dal gioco di Hillman.
«È stato un onore portargli le borse. – dice sorridendo placidamente – Non avevo mai visto nulla del genere. Le schiacciate erano “ridicoulous” e le stoppate…..le stoppate qualcosa di “absurd”! Un tempismo perfetto. Darnell Hillman era veramente grandissimo.»
Con queste credenziali anche Team USA, guidato da Hal Fischer, si accorge di lui e lo vuole in squadra per partecipare ai campionati del mondo FIBA, che si sarebbero svolti in Jugoslavia nell’estate del 1970. Darnell accetta di buon grado la chiamata e si ritrova a far parte di una squadra, che può contare su elementi del calibro di Kenny Washington (due volte campione NCAA sotto Wooden a UCLA fra il ‘63 e il ‘66), Garfield Smith (già suo compagno fra gli All-Stars), Michael Silliman (giocatore di Knight a West Point) e Bruce McDonald (piccola e fulminea guardia da Cedarville College).
Fra gli americani c’è anche un ragazzo giovanissimo, un po’ brufoloso, spilungone e con i capelli rossi, che non dovrebbe essere lì, visto che ha solo 17 anni e non ha ancora cominciato il college. Eppure è lì. Certo, è spaesato, inesperto, ma è lì. È un figlio della California, proprio come Darnell. È Bill Walton. Così come aveva fatto con Coach K, Darnell strega, con il suo modo di giocare, anche il giovane Walton.
«Mi schiacciava sempre sopra la fronte in allenamento. – ricorda Bill con un largo sorriso e la sua voce profonda – Qualcosa di incredibile. Addirittura nel warm-up prima di una partita, con una schiacciata violentissima fracassò il vetro del tabellone. Una cosa che in Europa non erano abituati a vedere. Tant’è che cominciarono a fischiarlo, perché a causa sua la partita avrebbe subito un ritardo. Darnell si spaventò e si sentì in colpa, al punto di scappare dallo stadio. Per fortuna un agente della security lo riconobbe al di fuori del palazzetto e lo ricondusse dentro! Non so come avremmo fatto senza di lui.»
La spedizione americana in Jugoslavia, tuttavia, nonostante un Darnell Hillman da circa 10 punti e 7 rimbalzi a partita, con un exploit di 23, segnati nella partita d’accesso alla fase finale del torneo contro la Cecoslovacchia, si conclude con un mezzo fallimento e Team USA si piazza al di fuori dei posti medaglia, agguantando un 5° posto. Nel ’71 Darnell si consola da questa batosta, vincendo nuovamente, assieme all’All-Star team, il campionato AAU, concludendo, con questa vittoria, la propria esperienza nel basket amatoriale.
Per Darnell ormai è tempo di passare al livello successivo. É tempo di iniziare a confrontarsi con il basket che conta, il Basket dei Pro.